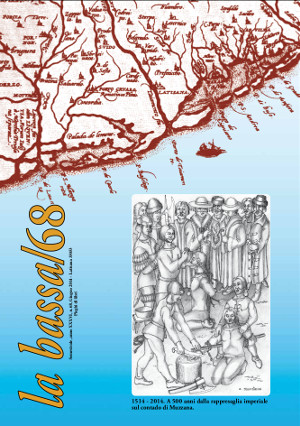
la bassa/68
anno XXXVI, n. 68, giugno 2014
Estratti di
articoli e saggi
della nostra rivista
In copertina:
Particolare della carta
Fori Iulii accurata descriptio
dal “Theatrum Orbis Terarum” di Abraham Ortelius (1527 - 1598)
Anversa 1573.
1514 - 2014.
A 500 anni dalla rappresaglia imperiale. sul contado di Muzzana.
Sommario
- ADELMO DELLA BIANCA - RENZO CASASOLA
1514 - 2014. A 500 anni dalla rappresaglia imperiale sul contado di Muzzana. - MAURO FASAN
La chiesa S. Giovanni Battista di Meduna - ROBERTO TIRELLI
La vicinia di San Vidotto ed il suo libro degli istromenti - MONICA MINGOIA
Quando si tratta di noi - MAURO BULIGATTO
1601 Testamento fatto per mi Soldoniero Strasoldo - ENRICO FANTIN
Dopo cent'anni onorati i 18 Caduti latisanesi della Grande guerra - MONICA MINGOIA
Fede - GIANNI STRASIOTTO
Il blasone popolare scomparso - GIACOMO TASCA
Opere poco note di Vincenzo e Guido Cadorin nella destra Tagliamento - BENVENUTO CASTELLARIN
Nomi di luogo e leggende nella Bassa friulana - ROBERTO TIRELLI
San Paolo, san Polo intinerari devozionali nelle basse e non solo - CRISTINA BENIGNO
Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista*
(seconda e ultima parte) - MARIA TERESA CORSO
Cognome LUGNAN - DON GIOVANNI SCHIFF
Si viarzin lis scuelis - ENRICO FANTIN
Un documento del 1912 sulla costruzione della chiesa di Gorgo di Latisana - GIORGIO MILOCCO
Il conte Pace di Tapogliano sul Col di Lana - CARMELA DE CARO
Giacomo Gasparotto e i prigionieri di guerra alleati - GIANNI STRASIOTTO
Calendario - ROBERTO TIRELLI
Conflitti territoriali diocesani (il caso di Brussa e Castello) nella bassa concordiense - ENRICO FANTIN
I ragazzi del '99 e cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto - MONICA MINGOIA
Speranza di Pace - MARIA TERESA CORSO
6° premio Ghin Valerio 16 febbraio 2014
Tema: Risorse della laguna - navigabilità e la nautica dell'area - RENZO CASASOLA
Il “fundum Mucianum” note sulle ragioni di una donazione
1514 - 2014.
A 500 anni dalla rappresaglia imperiale sul contado di Muzzana
ADELMO DELLA BIANCA - RENZO CASASOLA
Cinque secoli sono trascorsi dagli efferati fatti accaduti alla villa marchesca di Muzzana ed ai suoi abitanti in quel tragico marzo 1514. Accantonate da tempo le reminiscenze, di ciò che successe allora, vi è rimasta una sola traccia nell'allegoria apposta sullo stemma comunale.
Tra gli innumerevoli e tragici eventi bellici che la locale popolazione dovette subire lungo la sua travagliata storia, la rappresaglia attuata dagli imperiali al comando del capitano di Gradisca, il croato conte Cristoforo Frangipane, rimarrà nella storia locale e, non solo, come la più efferata, cruenta, crudele perpetrata ai danni di una popolazione inerme. Da allora, per la nostra comunità, in futuro nulla sarà più come prima. Di ciò che successe non vi è spazio per la retorica, parlano i fatti, e i fatti sono noti. Valenti autori di storia locale, da M.G.B. ALTAN a R. TIRELLI, ne discussero in precedenti contributi, ma poco se ne parlò sull'aspetto sociale, emotivo ed umano della vicenda, tema sul quale ci soffermeremo. Riassumiamo perciò brevemente i fatti: siamo agli inizi del XVI secolo, periodo storico in cui si svolse la feroce guerra tra la Serenissima e l'Impero asburgico. Tutto ebbe inizio con la morte nel 1500 di Leonardo, l'ultimo conte di Gorizia passato a miglior vita senza eredi. L'imperatore Massimiliano d'Austria ne rivendicò allora, per la corona asburgica l'intero territorio della Patria del Friuli, quale legittimo feudo imperiale. La guerra con la repubblica veneziana, che in parte ne controllava già il territorio, fu pertanto inevitabile. Nella Bassa friulana, il punto strategico per il controllo dell'entroterra friulano fu la fortezza di Marano, ritenuta imprendibile e saldamente in mano alla Serenissima. Solo con uno stratagemma però, nella notte del 13 dicembre 1513, il prete Bortolo da Mortegliano in accordo con il vescovo di Lubiana Cristoforo Rauber, permise agli arciducali del Frangipane di entrare in forze nella fortezza e, senza colpo ferire, estromettere da essa la sguarnita ed allibita guarnigione veneziana.
Non potendo in seguito garantirne l'approvvigionamento dei viveri via mare, controllato dalla flottiglia marchesca, per l'accesso alla fortezza friulana gli imperiali seguirono necessariamente la via più difficile, ovvero l'attraversamento delle insidiose paludi e l'oscura ed infida foresta muzzanese, poste nell'immediato entroterra. Paludi e boschi furono terreno ostile ed insidioso per chiunque, ma non per i muzzanesi, che di ogni palût e troi ne conoscevano i più reconditi segreti. Le cronache dell'epoca ci riferiscono che, i nostri villici legati alla Serenissima, istigati e guidati da Camillo di Giovanni Colloredo - loro potente signore feudale - nel dicembre 1513, gennaio 1514, iniziassero ad intercettare sistematicamente i rifornimenti provenienti dal goriziano e diretti alla fortezza maranese, attraverso le paludose boscaglie perilagunari.
Il DI MANZANO, allora definì gli abitanti di Muzzana: “…gente avvezza in quei tempi alla rapina, molestavano i convogli delle vettovaglie dirette agli austriaci di Marano”. Su questa - per noi muzzanesi - non felice affermazione, già ci si potrebbe soffermare per alcune considerazioni; ad esempio, estrapolando il vissuto, la contingenza bellica e l'indigenza popolare di quel periodo storico che ne motivarono l'azione. Lo stato feudale che perdurò su queste terre per oltre un millennio, dovette condizionarne pensieri ed atteggiamenti, esacerbò gli animi, ne favorì le azioni. Cogliere le opportunità che l'ambiente offriva, qualunque esse fossero, fu una necessità vitale per sopravvivere in una società che nulla dava, ma che molto pretendeva. Pertanto, in quel periodo di guerra, le imboscate ai danni dei fornitori si susseguirono con regolarità, con la confisca sistematica delle preziose derrate alimentari. Ci riferisce il CANDIDO che: “Mentre si combatea Osopio i contadini di Mutiano, uccisi i messi di Cesare, saccheggiarono quel formento, il quale mandarono quei di Marano al molino…”. Il culmine di questa attività banditesca, venne raggiunto però con l'uccisione dei due messi imperiali diretti alla fortezza maranese, fatto questo che fornì un ottimo pretesto per scatenare l'immediata e violenta rappresaglia imperiale.
Cristoforo Frangipane, già temuto signore di Veglia per l'efferatezza delle sue azioni militari, al comando di un numeroso contingente di arciducali, piombò di sorpresa sul villaggio di Muzzana il primo marzo 1514, circondò il paese e catturò un gran numero di persone di ogni età. Senza possibilità di fuga, i villici vennero radunati e legati sulla piazza principale, dove furono lasciate libere le donne, ma trattenuti gli uomini. Ciò che successe effettivamente in seguito è difficile da stabilirsi, in quanto le versioni fornite dai commentari di allora sono discordanti, ma vi è concordanza sull'efferatezza ed estrema crudeltà della ritorsione.
Il Frangipane, evidentemente, dopo aver: “…scorso le ville lì attorno, si accanì particolarmente contro i villici di Muzzana”, giusto per ribadire chi fossero i nuovi padroni ed intimidire così, con la violenza e la feroce repressione, le popolazioni circostanti. Legati come bestie, ed a piedi, gli uomini vennero deportati nel campo di Gemona - città già sottoposta al controllo imperiale - dove, dopo aver trascorso il primo giorno senza viveri né acqua, venne inflitta loro una tremenda punizione il 2 marzo. Riferisce il CERGNEU che: “…senza che processo alcuno formato fosse né dato alle escusationi ascolto”. Secondo il SANUDO, gli uomini sottoposti alle feroci ed inaudite torture cui seguirono le invalidanti mutilazioni furono: “…zerca 115…”, per il CANDIDO si scende a: “104 giovani e vecchi” e, per il CERGNEU ancora di meno: “…furono omini quaranta di anni vinti in su e giovani circa dodici”, infine, l'AMASEO ci riferisce di “...101 homeni e …putti con stigmate”. Da una nota apparsa su “Il Paese”, del 2 marzo 1907, “ai centouno prigionieri di Muzzana, il 2 marzo 1514 si aggiunsero altri 53”. L'AMASEO ci fa notare che a questi disgraziati dai vent'anni in su, fece: “…li occhi per mano del carnefice estrarre et alli giovani a quale un occhio estrarre fece a quale una mano tagliare et alli putti in lo viso con tagliente et adusto ferro una croce per guancia imporre fece, cosa miseranda e turpe da vedere, tanti poveri privati de si grande sentimento”.
Ancora l'AMASEO, in un'altra relazione ci fornisce più particolari sulle bestialità commesse dagli imperiali sui muzzanesi: “Per haver la villa de Mozana intercepte le victuarie che andavan a Maran fo afirmato esser sta in Gjemona per comandamento del conte Cristoforo excecati 56 Homini de tuti e do li occhi, zoè li più vechi, et li altri più zoveni excecati de un solo ochio et tagliati li tre diti per uno de man destra, zoè lo police et indice et lo medio, azò fosero inutili a l'arco et a la milizia, et li putti signando lo volto in croxe cum stigmate cum summa admiration de tuti (…)”. MARIN SANUDO, cronista veneziano e contemporaneo ai fatti, nei suoi Diarii ci fornisce una sua versione dell'accaduto, in cui: “…zerca 115 fece a quelli di anni 60 in suso cavar tuti do li occhi a da lì in zoso uno occhio e do deda de la man destra”. Anche il DI MANZANO riferisce che: “Perché fece egli (Cristoforo Frangipane) cavar gli occhi a più che 60 cittadini, a molti altri un solo, diversi segnò in faccia e ad alcuni fè tagliare le dita delle mani”.
Gli occhi cavati agli uomini ed ai ragazzi, vennero posti in un bacile ed inviati nella fortezza di Marano, come tragica, macabra e terribile prova della rappresaglia sui muzzanesi. A questa dolorosa e orribile rappresentazione, lo stesso Frangipane catturato già alla fine di quello stesso anno dai marcheschi, nei pressi di Gradisca, riferì ai magistrati veneziani che furono ad assistervi: “…lui conte, el vescovo de Lubiana Cristoforo Rauber (sic!) e quatro conseieri cesarei, li quali voleano apicarli e lui volse più presto farli orbi li occhii e alcuni tajar li dedi et cussì“ fu fatto et tutti li occhi fo portati in un bazzil”.
Da quanto asserito dal conte, parrebbe che il suo intervento avesse evitato la morte per impiccagione ai muzzanesi, convertendo viceversa la pena capitale in una lenta agonia…, forse ancor meno dolorosa? L'AMASEO conferma la presenza del prelato: “Adi 2 marzo fece la strada in Udine lo reverendissimo vescovo della Casarca Majestà di tutta la Patria del Friuli et udì ditti fo cavati li occhi in Gemona per comandamento del conte Cristoforo Frangipane a circa 101 homeni de Muzzana et accecati loro putti segnando lo volto in croce cum stimmate”. ed ancora: “Cristoforo Rauber, vescovo de Lubiana voleva appicare quegli infelici, rei della loro fede inconcessa verso la repubblica”.
La chiesa S. Giovanni Battista di Meduna
MAURO FASAN
Le pievi di Meduna, Sacile e Aviano, oltre ad altre già appartenenti all'abbazia di Sesto, sono le poche istituzioni, poste ai confini occidentali della diocesi di Concordia-Pordenone, un tempo soggette al Patriarcato di Aquileia. Meduna venne annessa a Concordia solo nel 1923.
La costituzione della pieve di Meduna risale certamente a tempi remoti, ma non si hanno informazioni utili a riguardo. Sono state avanzate le ipotesi che la prima chiesa fosse succursale di quella di Lorenzaga (ben più antica), o addirittura della chiesa di S. Paolo di Pasiano, dalla quale si smembrò anche la vicina Brische (circa 1498).
Si potrebbe ipotizzare l'origine della parrocchia di S. Giovanni Battista di Meduna nell'anno 1220. L'11 aprile, infatti, l'abbate di Sesto consegnò al patriarca di Aquileia la villa Erbasecca (da allora Corteabbà) definendo così i confini e forse anche la nascita della parrocchia medunese. Parrocchia che fino al 1926 si estendeva sul territorio entro le mura e i fossati della fortezza, comprendendo però Corteabbà.
Tuttavia questa teoria non è avvalorata da alcun documento e pare che l'erezione canonica della parrocchia sia coeva del periodo di governo pastorale del vescovo di Concordia Enrico Strassoldo e, precisamente, riconducibile al 1430. Allo stato delle ricerche non è possibile stabilire il momento in cui la pieve di Meduna prese la propria autonomia e la questione merita uno studio più approfondito. Non è da escludere che l'importanza politico-militare del castello medunese avesse generato ben prima del XV secolo le condizioni per creare una parrocchia autonoma e di libera collazione; giustificando la teoria, da alcuni condivisa, della presenza della pieve medunese prima della fine del XII secolo.
L'incertezza circonda anche l'erezione della chiesa stessa. Il primo edificio (non l'attuale) dev'essere stato contemporaneo del castello. Anche in questo caso mancano documenti probatori, ma tale opinione può essere accettata senza grandi difficoltà.
Tuttavia è del 4 maggio 1363 il primo documento che parla della chiesa di Meduna. Quel giorno il notaio sanvitese Gaudioso verbalizzò la volontà del patriarca Ludovico della Torre, desideroso di accontentare i suoi devoti sudditi della Meduna, che diede facoltà al vescovo di Concordia (Guido III de Barzis) di consacrare la chiesa da poco restaurata, dedicata a S. Giovanni Battista.
In quell'occasione il patriarca concesse la possibilità di tenere a Meduna un mercato libero, cioè esente da tasse, due volte l'anno: il giorno della consacrazione della chiesa e il giorno della decollazione del santo eponimo (29 agosto). Le fiere si tenevano esternamente alle mura castellane, in uno “slargo” che corrisponde all'attuale piazza Umberto I.
Legata alla consacrazione era la sagra paesana, che nel 1988 compì 625 anni e poco dopo fu soppressa. Delle due fiere autorizzate dal patriarca, si mantenne solo quella del 4 maggio, che all'epoca della Serenissima venne ricollegata alla festività di Pentecoste, con la convinzione che la chiesa fosse stata consacrata in quel giorno.
In età moderna la festa divenne sagra (una delle più antiche della zona) che alla fine del Novecento venne eliminata e, con essa, scomparirono oltre sei secoli di storia.
Tornando al 1363, è significativo notare come il patriarca specifichi che la chiesa sorgeva sulle rovine di quella precedente, sempre dedicata a S. Giovanni Battista, della quale si era persa ogni memoria della consacrazione.
Di questa chiesa oggi rimangono solo il campanile e due possenti mura, riaffiorate nel 1971 durante operazioni di scavo lungo via Vittorio Emanuele per la posa di tubazioni.
La chiesa, che oggi domina il centro del paese, è stata costruita ex novo e consacrata l'11 febbraio 1545 da monsignor Egidio Falcetta.
Falcetta, vescovo di Caorle, poco più di un mese prima aveva iniziato la visita pastorale della diocesi aquileiese per conto del patriarca Marino Grimani. Giunto a Meduna a laude et gloria del Eterno Iddio, et consolatione de esso Populo cosecrato la Chiesa. Il presule approfittò anche per benedire il cimitero e le campane alla presenza di grandissimo numero de populo.
L'edificazione della chiesa fu possibile grazie all'intervento della nobile famiglia veneziana Michiel, capitani di Meduna, che finanziarono i lavori, preservandosi la tomba di famiglia all'interno.
La tomba era stata ricavata sotto il presbiterio, con accesso dall'esterno. Per scendere nella cripta bisognava, infatti, entrare nel cimitero parrocchiale, allora accanto alla chiesa, e da questo scendere nell'interrato tramite una scala.
Nonostante l'esoso impegno economico, i patrizi veneti non poterono servirsi della cripta perché nel 1584, in occasione delle visite del De Nores, fu ordinato che sii levato il sepolcro delli Illustrissimi Signori Michiel che è nella capella maggior in termine di un mese e chi vorà contradire sii scomunicato di scomunica maggiore et non possi esser asolto altro che dal Papa.
Tuttavia i Michiel riuscirono a conservare il sepolcro all'interno della parrocchiale. Fino al 1966, infatti, al centro della navata c'era la pietra tombale di Giovanni Francesco Michiel, oggi conservata nel muro della sacrestia. Su di essa è scolpito lo stemma di famiglia e vi si legge: in […] o viro patritio v. / Ioan. Franc. / Iacobi F. patris / ac matris suae cineribus / huc traslatis ex / testamento dicarunt / f. p. / obiit mdlxxxx / pridie calendas ianuarii.
È da supporre che lo spostamento della tomba fosse imposto dai nuovi dettami controriformistici, da cui fu largamente condizionata la visita pastorale, e che in questo nuovo clima il presbiterio (capella maggior) apparisse al visitatore apostolico un luogo troppo importante per essere dedicato agli interessi privati di una sola famiglia, per quanto la più illustre del paese.
La questione della cripta ha dato modo di riflettere su un particolare architettonico che caratterizza la chiesa medunese.
Il sacro edificio, a unica navata larga 10,50 m, lunga 20,80 m e alta 10,90 m, ha la particolarità di essere orientato con l'abside verso ovest, contrariamente ai canoni architettonici dell'epoca. Questo porterebbe a pensare che originariamente l'edificio fosse pensato con l'ingresso rivolto verso il fiume Livenza e in seguito girato e posto al centro del paese, senza escludere una costruzione in fasi successive: una per edificare la sola navata, consacrata nel 1545, e una seconda per costruire il presbiterio sopra la cripta (prima del 1584).
La vicinia di San Vidotto ed il suo libro degli istromenti
ROBERTO TIRELLI
I libri antichi sono già di per sé affascinanti. Lo sono ancor più se evocano una realtà scomparsa nei secoli eppure ricordata come ancor viva proprio dalla testimonianza scritta, che rende il tempo e gli uomini del passato all'attualità. Il libro degli istromenti della vicinia di San Vidotto, paese distrutto dalle orde turchesche nel 1477 e mai più ricostruito, riporta nei suoi contenuti il prosieguo di una consuetudine che vede il ritrovarsi di famiglie di Flambro e di Lestizza unite dalla comune origine in quel villaggio.
Nel XVII secolo sui luoghi ove si trovavano le macerie dell'antico luogo abitato venne edificata una chiesa campestre dedicata a Sant'Antonio Abate nella quale entrambe le comunità celebravano il rito del ricordo. I beni cospicui della vicinia in terreni ed edifici, oltre che in denaro liquido conducevano ad impiegare rilevanti somme in prestiti (livelli) ed altre operazioni finanziarie ad interesse, i cui vantaggi erano per la chiesa e la comunità.
Così inizia il gran libro con la copertina di cuoio: “Libro istromenti della veneranda chiesa di Sant Antonio di San Vidotto.
P. Valentino Comuzzo
Fatto sotto la cura del rev.do signor don Camillo Cojutti vicario di Flambro e altre ville annesse 1679”.
Tutto ruota attorno alla religiosità e le riunioni della vicinia avvengono con “invocato il nome del Signore Iddio”. Sebbene gli orari delle riunioni risultino spesso strani, al levar del sole oppure al suo tramonto l'istituzione pare funzionare.
Prendiamo ad esempio un atto del 1745 con il quale viene data a livello fiancabile al quattro per cento di interesse (prestito riscattabile) al Comune di Lestizza la somma di 200 ducati:
“Giorno di venerdì li 9 aprile 1745 in Flambro.
Comparve personalmente appresso di me notaio e seguenti testiis ser Michiel quondam Zuanne Toneatto di questa villa attuale podestà del Comune di San Vidotto che riferse aver statta questo giorno convocatta la vicinia del suo Comune previo il solito invito al luogo stabilito, more, modo, loco solito convocarsi et in questa sono intervenuti gli infrascritti uomini cioè:
| Michiel Toneatto suddetto attuale podestà et | Valentino di Zorzi giurato |
| Sebastiano Lorenzutto | Valantino Pertoldo |
| Lorenzo Toneatto Utizia | Sebastiano dei Faris |
| Giacomo Toneatto | Rugier Pertoldo |
| Batta Blasone | Gioseffo Pertoldo |
| Dominico di Taddio | Pietro Pertoldo |
| Tutti di Flambro | Tutti di Lestizza |
Detti uomini componenti il Comune stesso et in quella fu proposto dal predetto Podestà che il Comune et uomini di Lestizza ricevano a livello fiancabile ducati 200 in ragione della veneranda chiesa di Sant Antonio di San Vidotto in ragione di pagar a quattro per cento con la piaggeria con principalità di ser Gio Batta di Giusto di Lestizza e del Comune suddetto. Fu ben intesa tal istanza e doppo fatto il solito colloquio quale usanza in detta vicinia, fu a pieni voti deliberato che ser Francesco Maddalena cameraro attuale di detta veneranda chiesa abbia ad sborsare li suddetti 200 ducati di lire 6.4 l'uno al predetto Comune et uomini di Lestizza con la piaggeria di sopra rifferita in ragion di 4 per cento destinando a tal effetto Lorenzo quondam Sebastiano Toneatto di Flambro uomo del Comune assieme al cameraro alla stipulazione dello istrumento, ma che prima debba il cameraro ricorrere alla giustizia e supplicare il nobile et eccellentissimo signor capitano di questo mobilissimo contado di Belgrado degni premettere la sua autorità preziosa e giudiziale decreto all'instrumento da celebrarsi per maggior cautione di esso per ogni buon fine et effetto”.
Come si legge il controllo sugli atti avviene direttamente dal Capitano della Contea di Belgrado che ha ufficio in Bertiolo e fa capo al giurisdicente Mario Savorgnan del Monte e della Bandiera, il quale oltre ad essere lui stesso debitore nei confronti della vicinia se ne fa censore quando nota che i camerari in occasione della festa di Sant'Antonio fanno eccessive spese sumptuarie minacciano estremi provvedimenti.
Quando si tratta di noi
MONICA MINGOIA
A volte penso alla vita, alle sue contraddizioni,
agli anni passati tra gioie e dolori.
Noi che pensiamo ad andare avanti
e che non pensiamo alla vita degli altri.
Ci sentiamo soli, a volte afflitti,
desolati degli sconfitti.
Pensiamo spesso: le preoccupazioni,
il nostro avvenire e le nostre ambizioni.
Tutto gira intorno a noi,
siamo stanchi, a volte eroi,
ma tutto si sgretola in un momento
e il nostro cuore batte a rilento,
quando all'appello siamo chiamati:
si tratta di NOI, siam NOI i nominati.
Tutto ci appare in una luce diversa,
tutto ci sembra una causa persa.
E allora in un attimo di riflessione,
capiamo la sofferenza, la delusione e la disperazione,
che le altre persone hanno nel cuore.
A volte pensiamo che siamo intoccabili,
non ci succederà niente d'irreparabile,
ognuno di noi si sente inviolabile, si sente unico, irripetibile;
questo è anche vero amico mio
però ricorda non solo il tuo Io.
Esistono popoli, esistono persone
che hanno tenebra dentro il cuore,
hanno sofferto, hanno subito v e molti di noi non hanno capito.
Capire cosa, una cosa vera, che per ognuno di noi arriva la sera.
Quindi ricorda amico mio vero
e te lo dico in modo sincero e
te lo dico in un momento: la vita cambia e
non ci sono eroi quando a soffrire:
Monica Mingoia - Latisana (UD).
1601 Testamento fatto per mi Soldoniero Strasoldo
MAURO BULIGATTO
Il casato nobiliare del nostro Soldoniero è compreso fra quelli più importanti e antichi della Patria (Cfr.: PASCHINI 1990, p. 250)1. Nei secoli la famiglia si rafforzò attraverso svariati conseguimenti patrimoniali. Va parimenti evidenziato che diversi suoi componenti rivestirono cariche politiche e istituzionali importanti. Le evidenze che emergono dalla genealogia della linea di Soldoniero sono varie. Citando le più vicine s'incontra il nonno. Questi, il cui nome fu assegnato per battezzare il nostro annotatore, ricoprì il ruolo di maresciallo alle dipendenze del conte di Gorizia, capitanando anche Castelnovo e Belgrado presso Varmo. Il padre Federico servì l'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, anche svolgendo compiti diplomatici. Lo zio Giovanni prestò servizio presso la corte imperiale, così come Soldoniero cronista. Questo ramo degli Strassoldo, avendo acquisito immobili e proprietà terriere a Belgrado di Varmo, a Chiarmacis nonché a Driolassa, fu molto legato ai territori della Bassa ove soggiornava in particolari periodi dell'anno (cfr.: ALBERTI - GEROMET 1999, p. 256).
Esponiamo qui la parafrasi di un estratto da “Cronache antiche friulane - Cronaca di Soldoniero di Strassoldo”. L'opera globale è un insieme di resoconti familiari e storici, redatti dall'innanzi citato nobile friulano, che abbraccia principalmente il XVI secolo. Per opera del canonico Ernesto Degani il manoscritto di famiglia fu trascritto e fatto pubblicare, grazie all'Accademia Udinese, nel 1895 (Cfr.: DEGANI 1895, pp. 70-75)2. Ma veniamo al documento di inizio secolo XVII.
Le ultime volontà del nobile Soldoniero furono vergate in forma autografica nella città di Udine. Scendendo subito nel particolare riportiamo che il fatto si svolse nel borgo di Aquileggia, ne la parte de drio della habitatione, il 9 marzo del 1601. Tali ultime sue determinazioni furono materializzate attraverso un atto che previde pure la presenza di ben otto testimoni e, fra questi, il mis. Francesco Brugnalesco nodaro. I testi furono convocati per dare peso giuridico “alla carta”. E difatti, a tal proposito, il testante acclara: la quale voglio che vaglia come se di man di publico notaro fosse scritta3. Lo stimiamo, questo, come un gesto eseguito ad abundantiam, oltre il bisogno. Sia pure con una qualche alea lo consideriamo, come una supplenza a livello psicologico a un'incalzante necessità di assicurare, post mortem, il pieno svolgimento delle proprie disposizioni. E come si avrà modo di verificare, dalla disamina del testo, le preoccupazioni di Soldoniero vanno ben oltre a un'elencazione di beni da spartire, mentre esiste cura massima verso i soggetti familiari: siano essi da tutelare ovvero da rapportare al godimento del patrimonio. Paradossalmente un ulteriore fattore che sostiene il nostro protagonista è una sorta di fragilità contingente, che deriva dalla sua età anagrafica: siamo all'inizio del XVII secolo, epoca in cui raggiungere settantasei anni è cosa rara anche per un nobile. Come di seguito si avrà modo di spiegare in dettaglio, il fardello è gravato inoltre dalla presenza di otto nipoti rimasti orfani, per i quali le preoccupazioni non mancano. Perciò come lui stesso annota, temendo io il dubbio del evento de la improvisa morte non havesse a morire senza provedere et havere proveduto alle cose mie et de li beni miei, si comporta di conseguenza.
Il corpus testamentarius si apre, così com'era per consuetudine, con una forma invocativa al Signore e difatti, in tale passaggio, troviamo la seguente espressione: In primis quidem l'anima mia et lo spirito mio recomando humilmente al eterno et omnipotente sig. Iddio. A tergo di questa si precisa subito che le spoglie mortali siano custodite nel Domo di Udene, affinché possano stare accanto a quelle del fratello Federico e degli altri parenti lì tumulati. Lo Strassoldo si dimostra preciso sull'argomento e, così come fece in occasione delle esequie del fratello maggiore assassinato, non tralascia nemmeno certi particolari riguardanti il proprio accompagnamento alla tomba. Una tantum egli lascia dieci staia di frumento alla Confraternita del Cristo di Udine. Ciò a titolo di riconoscimento, affinché tutti quei fratelli che vorranno condurlo siano provvisti di candela, da sei soldi, et così al Santissimo Rosario. Lui inoltre rivolge l'auspicio d'essere sepolto con gli onori che si convengono e che, a parere de li Heredi, in vita ha meritato.
Alla consorte Andriana conferisce l'usufrutto: la possibilità di godere de tutti li beni mobili et stabili di ciascaduna sorte. Ella non dovrà in alcun modo rendere conto ai nipoti. Questi ultimi, così come vergato dalla mano di Soldoniero, saranno tenuti a osservare, in ogni modo, la consegna dell'obbedienza ed essere contenti et taziti di questa ultima sua volontà. Esiste poi un'esplicita menzione al concetto di necessario mantenimento dell'armonia fra membri del clan (....che debbiano stare et vivere amorevolmente insieme con essa et tutti insieme....): questo non di certo per delle mere questioni morali primarie da rispettarsi. Crediamo che tale regola sia stata apposta, anche, per assolvere dei motivi di mantenimento di una certa immagine verso l'esterno e per i benefici derivanti da tale condotta (....così facendo saranno da tutti stimati, reveriti et parimenti da tutti temuti....). All'interno del documento si distingue una parte indirizzata ala ettà di volersi qualcun di essi fratelli maritarsi per ampliare la nostra famiglia. Per la fattispecie egli dispone che i nipoti (maschi) si riuniscano e consultino per stabilire quale sia il più accreditato al proposito, per honorevolezza et utilità de la famiglia. In aggiunta l'eletto dovrà essere ratificato con bona licentia dalla signora Andriana. Nel caso di una qualsiasi disubbidienza, quel nipote sarà privato di ogni eredità spettante. Ciò sempre in virtù di quel principio ispiratore innanzi detto, e rinnovato, di vita in santo amore. La prescrizione rimaneva estesa anche ai nipoti non investiti dell'onere del matrimonio.
A proposito di tale sacramento cristiano Soldoniero ammonisce sull'estrema necessità di avere dei prosecutori della linea (....heredi Maschi....). Pertanto se il favorito dopo le nozze non havesse ne sperase havere ne fiolli ne heredi Maschi sarebbe automaticamente sostituito e scatterebbe l'ordine di cernere fra i restanti maschi, reiterando fino al rispetto delle clausole: fino a quando quel tale sposato haverà fiolli et heredi Maschi. La sezione dedicata alle questioni matrimoniali si amplia allorquando il nostro nobile impartisce disposizioni, a riguardo delle due nipoti femmine: Chiara tredicenne ed Elena di cinque anni. Per la maggiore è previsto che in età propizia dovrà esser fornita di una dote nuziale pari a duemila ducati, eventualmente aumentabile di quanto i fratelli potrebbero eventualmente acconsentirle e di quelle raggioni dottali derivanti dal patrimonio disponibile della defunta madre. Nella situazione in cui non si potrà solvere tramite liquidità (....dare li denari in tanti contadi....) si dovrà surrogare il tutto con un eguale valore, fatto di beni materiali del patrimonio. Dopo tale paragrafo il testamento è strutturato con un successivo vincolo, sempre riguardante il connubio della nipote maggiore: previo consenso familiare dovrà impalmarsi con un gentiluomo nobile et degno de la nostra famiglia et non altrimenti. Contravvenendo a tale principio la dote stabilita andava decurtata a un decimo della cifra iniziale: duecento ducati e senza null'altro a pretendere. Per la nipote minore Elena si determinava, qualora fosse stata concorde, di introdurla alla vita monacale (....in qualche honorato Monasterio o di questa città over fuori....) provvedendola di tutte le sostanze materiali necessarie per un onorato vivere in preghiera. In carenza della vocazione e stante il desiderio di maritarsi era contemplata la parità del trattamento, in linea con le disposizioni già emesse per la sorella maggiore. Per le due figiolle le condizioni limitanti furono poste anche su un'ipotetica situazione di mancata maternità. La dote in simile frangente doveva essere restituita alla Casa cioè: ali suoi fratelli et ali suoi heredi. Qui si completano le indicazioni a loro carico e, come verificabile dalla trascrizione del testo originale nonché dalle conseguenti annotazioni, si potrà arguire che gli eredi testamentari del patrimonio restarono i sei nipoti maschi.
Dopo cent'anni onorati i 18 Caduti latisanesi della Grande guerra
ENRICO FANTIN
Diciannove anni addietro, prima come segretario e poi come presidente dell'Associazione culturale “la bassa” avevo indirizzato al Sindaco una richiesta scritta per inserire sulla facciata lapidea del monumento ai Caduti i nomi “dimenticati” di 18 giovani militari latisanesi morti durante e a causa della Prima guerra mondiale.
È durata un arco di quasi vent'anni per veder esaurita la nostra richiesta di inserire quei nomi di nostri concittadini, tanto da sembrare che una semplice richiesta così doverosa e civile abbia così tanto penato.
Ecco i nomi dei Caduti, ignorati dalla storiografia ufficiale:
Altan Domenico di Angelo, cl.1884, Bigotto Giovanni di Giuseppe, cl. 1889, Bivi Alessandro di Luigi, cl. 1887, Braida Giuseppe di Michele, cl. 1895, Cecconi Ottavio di Vittorio, cl. 1894, Cesca Girolamo di Luigi, cl. 1888, Cicuttin Giacomo di Francesco, cl. 1890, Faggiani Giuseppe di Clemente, cl. 1889, Fantin Luigi di Giovanni, cl. 1898, Furlan Primo, cl. 1897, Gardin Giovanni di Giacomo, cl. 1884, Gobbato Giuseppe di Pietro, cl. 1884, Gobbo Luigi di Anselmo, cl. 1898, Margheritta Valentino di Pietro, cl. 1888, Marosa Luigi di Federico, cl. 1884, Paron Angelo di Pietro, cl. 1889, Urban Emilio di Cesare, cl. 1882, Valvason Giovanni di Giuseppe, cl. 1893.
La domanda era stata inoltrata nel 1994, anno in cui la nostra associazione aveva dato alle stampe il libro: “Vicende belliche nel latisanese. Dai saccheggi napoleonici alla seconda guerra mondiale”. Le nostre ricerche portarono alla scoperta che diversi nomi di caduti latisanesi, peraltro inseriti nell'”Albo d'Oro”, non erano stati scolpiti nel monumento cittadino posto davanti le Scuole elementari di Viale Stazione. Una seconda richiesta venne da me trasmessa nel 1998 in occasione di una nuova pubblicazione dal titolo: La Bassa friulana nella Grande guerra 1915-1918. Anche questa volta senza alcun positivo risultato (fig. 1).
Con l'insediamento del nuovo sindaco, Micaela Sette, nel 2001, la richiesta pareva volgere a buon esito, tanto che fu dato alle stampe un libricino, a mia firma, stampato a mie spese, con l'elenco di tutti i nomi dei Caduti della Prima e anche della Seconda guerra mondiale (fig. 2). La cerimonia doveva svolgersi ai primi di novembre del 2002 in occasione della festa delle Forze Armate. Purtroppo, per ragioni a me sconosciute, la targa con i nomi dei 18 Caduti non venne posta nel monumento. Ugualmente vi fu una dignitosa cerimonia con la compartecipazione dell'U.N.I.R.R., dove vennero consegnate ai familiari dei Caduti e dispersi in Russia una medaglia a ricordo. Il libricino fu parimenti distribuito, in omaggio, ai partecipanti la cerimonia.
Nel contempo furono trovati ulteriori documenti a testimonianza della causa e furono riportati in un apposito capitolo “Soldati latisanesi caduti e dimenticati”, a pag. 51, di un terzo volume, dato alle stampe nel 2008, dal titolo: “La Prima guerra mondiale nel 90° della fine. Un itinerario della memoria fra il Carso e il Tagliamento, fra la Diocesi di Udine e Concordia-Pordenone (1918-2008)”.
Or bene detto volume fu inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con una lettera di accompagnamento dove si chiedeva “di aggiustare e rendere onore, seppur in ritardo, a quei nostri concittadini” (fig. 3). La Prefettura di Udine, aderendo ad un invito della Presidenza della Repubblica, in data 24 novembre 2010, mi comunicava che “…Il mancato accoglimento di tale richiesta, finora, è stato causato da difficoltà operative evidenziate dal Sindaco di Latisana. Tali difficoltà si riferiscono, in particolare all'identificazione dei latisanesi deceduti ed alle modalità da seguire per intervenire su un monumento storico con l'apposizione della targa ricordo”(fig. 4).
Tale risposta non mi soddisfece in quanto ero in possesso di copie di documenti del Ministero della Guerra, certificanti la morte dei soldati ed esisteva persino una tomba nel cimitero di Latisanotta; allora chiesi un appuntamento al Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine, dott.ssa Maria Rita Coluccia, per spiegare la vicenda e consegnare copia della documentazione. Il 17 gennaio 2011 fui ricevuto dalla dott.ssa Coluccia e le consegnai il plico e spiegato le motivazioni, al che ella si disse dispiaciuta di non poter essermi d'aiuto poiché doveva essere il Comune a decidere il prosieguo (fig. 5).
Di tutta questa intrigata vicenda ne venne a sapere il nuovo sindaco di Latisana, Salvatore Benigno, il quale mi chiese maggiori delucidazioni. Egli prese subito a cuore l'iniziativa telefonando al Capo di Gabinetto della Prefettura di Udine. Avuto conferma della richiesta si è subito rivolto al Ministero della Difesa, Sezione Albo d'Oro e al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra, che hanno risposto confermando che i nominativi segnalati dall'Associazione “la bassa” corrispondono ai loro elenchi (fig. 6).
Sono ancora convinto e resta tuttora valido di quanto scrissi nel 2002 e 2008 dei già sopra citati volumi:
Pur avendo trovato nomi nuovi da aggiungere al già abbondante e triste elenco dei gloriosi caduti latisanesi, penso che ci sia ancora molto da fare per ricostruire e integrare le diverse lacune in merito all'argomento. Già è stato difficile trovare questi nominativi dopo quasi cent'anni. Vuoti che più si trascineranno nel futuro e più difficili diverranno le ricerche, anche perché, inesorabilmente, l'oblio verrà a coprire questa mesta pagina di storia.
Tuttavia è stata collocata un nuova tessera nel grande mosaico della storia latisanese: un tassello di storia doveroso verso quei poveri ragazzi che pronti alla chiamata del dovere hanno immolato la loro giovane vita alla Patria. Una pagina seppur scritta in ritardo, vuole rendere onore alla loro memoria, a quella dei loro discendenti e affinché rimanga a perenne ricordo della loro cittadina. Una pagina che sarà senz'altro di aiuto ai futuri ricercatori e storici latisanesi.
Ma al di là di possibili disquisizioni siamo giunti finalmente ad una prima doverosa soluzione del problema segnalato da “la bassa”. Infatti, il 31 ottobre 2013 è stata posizionata la targa marmorea nel monumento cittadino con incisi i 18 nomi dei militi latisanesi ed inaugurata il 3 novembre in occasione delle celebrazioni della Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'opera è stata eseguita dall'artista scalpellino Attilio Zamarian, autore peraltro del restauro dello stesso monumento sventrato da un vile attentato fra la notte del 13 e 14 settembre 1971.
E ciò è merito del sindaco attuale di Latisana, Salvatore Benigno, che ha dimostrato una spiccata sensibilità civica e si è fatto parte diligente per avviare ad una involontaria incresciosa omissione.
Ringraziamenti
L'Associazione la bassa e il coordinatore dell'opera, Enrico Fantin, rivolgono un sentito ringraziamento a: Ministero della Difesa - Archivi di Stato Maggiore Esercito Italiano - Roma; il Capo Sezione statistica Previmil Cosimo Rao, del Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti in guerra e il direttore della 5ª Sezione “Albo d'Oro” Ten. Col. Giovanni Vergara Caffarelli.
Fede
MONICA MINGOIA
Fede di vita, fede religiosa, fede di una madre, una madre orgogliosa.
Fede di sognatori, di asceti, di monarchi, di imperatori, poeti, religiosi e patriarchi.
Religioni del mondo tutte riunite,
sotto un solo stendardo di preghiere esaudite.
Uomini in balia del vento, del cuore e delle passioni
che vivono sostenuti dalle loro convinzioni.
E allora fratello nella nera disperazione,
nella notte infinita e nel tuo grande dolore,
cerca la Fede e la consolazione
perché la Fede è tutto, è Speranza ed è Amore.
Monica Mingoia - Latisana (UD).
Il blasone popolare scomparso
GIANNI STRASIOTTO
Lo scorso anno “Il Popolo” ha pubblicato una ricerca su “Paesi e luoghi comuni”, riferita alle “caratteristiche”, un tempo attribuite agli abitanti di alcune località venete e ad altre - nell'area della diocesi di Concordia - dov'è parlato il dialetto veneto, con qualche incursione nel Friuli.
Con l'aiuto di alcune persone amiche, (soprattutto del prof. Angelo Bertolo di Fiume Veneto e di Stefania Agnolon di Barco), ho allargato la ricerca al resto della diocesi sui “titoli” - sempre dispregiativi - che i frazionisti di una località ricevevano da quelli dei paesi vicini, ricavando la certezza che molti altri si sono per sempre perduti.
Prima di riportarne i risultati, è necessario avvertire che alcune delle parole usate sono onomatopeiche (imitano suoni o evocano oggetti).
Questo è quanto riemerso faticosamente, e che potrà essere ulteriormente arricchito dall'apporto di qualche gentile lettore.
A più d'una località sono attribuite queste caratteristiche:
“Quei de … i copà el pedocio par tegner cont dea pel”, oppure “A … i è senza simitero, i more tuti in presòn”.
In almeno un paio di località, laddove gli abitanti portavano particolari copricapo fatti a mano dalle loro donne, c'era questo complimento: “A chei co la bareta, nessun ghe la peta”.
E' a tutti ben noto che gli abitanti di Cordenons vengono definiti “I folpi”, perché per generazioni venivano colà prodotti - in famiglia - degli zoccoli particolari, ricurvi, fatti a barchetta, (forma antiusura); erano aperti sul davanti, con una fascia di cuoio ed avevano il tacco. Erano soprattutto usati per il lavoro, ma venivano calzati anche dai bambini, che dovevano lasciarli fuori della porta della scuola, perché troppo rumoreggianti.
Dei cordenonesi viene anche detto che sono “I maestra gamberi” (non ci è stata una spiegazione plausibile sul significato).
Elenchiamo i “titoli” attribuiti alle altre località:
Cassiacco: Cassiac vergiars (per l'alimentazione a base di verze).
Anduins: Anduins ciocius (non è decifrabile, il termine non è riportato nemmeno dal vocabolario friulano del Pirona).
Bannia: A Bannia ogni porta ‘na stria, se no l'è la mare, l'è la fja.
Chei de Bania a ciàntin a subùlin (fischiano) a sùnis li ciampanis.
A tirin li fisètis di là da li montagnis (fisètis, pezzetti di carta incendiata, tirata con la fionda ad imitazione delle ben più note “cidulis”)
Brugnera: Quei de Brugnera i ‘ndea a farla ‘in tea panèra (secondo la tradizione popolare, sembra derivi da un'ingiuria - che avrebbe provocato una conseguente maledizione - fatta a prè Vincenzo Brocca, parroco dal 1818, morto nel 1826, colpevole di pretendere il giusto quartese. Un tempo veniva detto che la maledizione doveva estinguersi dopo due secoli…quindi mancherebbe ancora poco al termine). Ancor oggi, se qualcosa va particolarmente storto ad una persona, c'è qualcuno che sussura: “L'à la maedizion de don Brocca”.
San Vito: Chei de San Vio, i ‘à la cotua pi longia del vestio.
Scambio di cortesie: “Casarsa della Delizia - San Giovanni della sporcizia - Prodolone della scienza - San Vito della bellezza”.
Prodolone: “Prodolon lunc e stret, in ogni cjasa sta un puaret, ogni sun di ciampana, salta fora ‘na vedrana, la vedrana balerina, Prodolon senza farina.
Villotta di Chions: A Viòta i tira la campana (anziché pranzare, data la miseria), a Basedo i ghe corre drio a la pantegana (per ricavarne un pasto).
Chions: Cions scioso (secondo gli azzanesi) - Dazan (Azzano Decimo) peagroso (a detta dei chionsesi).
Cions dea porsea (forse una famiglia teneva un verro da riproduzione?).
Fagnigola: Fagnigòa, bugnigòa, frachignòa (o crichignigòa), i copa i pedoci co' la masuòa.
Prata: Chei de Prata, i vien fora quando che la fatura la è fata.
Praturlone: A Praturlon, i à copà el zingheno co el baston; po' le vegnù fora 'na vecjuta, che la à dat la so botuta. (riferito ad un fatto di cronaca avvenuto nel 1802 e che illustreremo in un prossimo numero).
Bagnarola: Bagnarola, schinciariola* - brutta zente, maldicente (*Schinchiariol è un cognome un tempo diffuso, forse c'era anche un piccolo borgo così denominato).
Marzinis: Marzinis frutinis (A fine ‘800 a Marzinis tre donne della stessa famiglia avevano oltre 40 figli).
Cordovado: A Cordovado, magnan verzis, magna brocui, i baracocui de Ramuscel (Ramuscello) (baraccocui = pesche-noci rustiche, ma qui il significato è piuttosto di teste dure) - Cordovado, longo e streto - ogni porta l'è el so beco - caminando su e zo - ogni porta el ghe ne 'a do.
Morsano: Morsan de li aucis (oche).
Tajedo: I codars di Taieit (I codars, contenitori fatti col corno di bue, per metterci la pietra da affilare la falce. Il fatto: un fedele l'aveva smarrito ed aveva chiesto al parroco di annunciarlo in chiesa per ottenere l'aiuto dei fedeli onde ritrovarlo).
Madonna di Rosa: Rosa, co la gosa - (il gozzo, sembra dovuto all'acqua da bere del posto).
Anche a Bagnarola c'erano i gosàrs (i gosàrs, venivano presi in giro, passandosi le dita della mano sul colletto della camicia).
Sempre contro i frazionisti di Rosa - tacciati da beoni - c'era il detto: Clinto fraulà nostran no'n ‘de (Nella località non c'era il vino clinto e neppure il vino di fragola, ma il nostrano sì. A questo punto s'imitava il suono delle campane del luogo, col caratteristico suono fesso, per umiliare i frazionisti, in quanto era sottinteso che non avevano il denaro che serviva per l'indispensabile rifusione).
Lugugnana: Chei de Lugugnane, i magna poc, ma i ridi tant.
Prodolone: Prodolon longo e stret, ogni porta l'è un poaret, ogni sun de ciampana, salta fora ‘na vedrana.
San Quirino: San Quirin, tira su che la vjot (Tira su la testa della vacca, in modo che possa vedere l'erba: ci si riferiva a quella del campanile, in quanto nei magredi - in certi periodi - non c'era proprio un filo d'erba verde).
Summaga di Portogruaro: Quei de Sumaga, i vien a tirar la paga. (Si erano creati la fama d'essere tutt'altro che lavoratori).
Tiezzo: Tiez bello, un prete solo: “Sior Piovan, el mandi via ‘na massera, el compri un capeàn”.
Tiez de la britule (gli uomini avevano sempre la roncola in tasca, anche come arma).
Cantilena: Villutta - Villotta - Pravisdomini e la Mota - Zut e vignut senza pissar 'na vota.
Corbolone di San Stino: Le femene de Corboòn, le sa dogar a la mora - le zoga a scopetòn, le bala col cul in fora.
Villotta di Chions: Villotta brusa Madone e brusa (copa) cristiani (si dice sia riferito a fatto di cronaca di oltre un secolo e mezzo fa).
Gleris di S.Vito: Gleris roba Madone (sembra che i parrocchiani abbiano scambiato, con quelli di Savorgnano, stremati per la fame, un sacco di fagioli per una statua - o un quadro - della Vergine in cattivo stato di conservazione).
Bogiòi di Gleris (non è chiaro il significato).
Carbona: La vacja Carbona ‘no l'è bona. (Un tempo la località era denominata Villa Bianchina. Vediamo perchè il nome ha subìto la variazione. Carbona è il nome che si dava alla vecchia vacca ossuta, non più in grado di generare, tenuta in vita per i lavori più pesanti, e questo nome venne attribuito da quelli di San Paolo di Morsano, per aver sentito due giovanissimi fratelli di Villa Bianchina litigare per spartirsi, appunto, un pezzo di carne d'una “carbona” macellata da quella comunità costituita da persone tutte parenti fra loro).
Concordia Sagittaria: Concuordia santa, zent briganta.
Scambio di cortesie tra Rauscedo e Domanins:
Domanins: Domanins ciaculins pantianatis e fora li culati (Domanins caccole di coniglio, pantegane e con fuori le chiappe), Domanins pantianat tic e tac l'omenat tal sac (Domanins pantegana, tic e tac l'uomo è nel sacco).
Rauscedo: Rosseit beif aseit magna ledan e tira la coda del ciàn (Rauscedo, bevi aceto, mangia letame e tira la coda del cane).
Una cantilena, in parte riepilogativa:
Crocs (teste dure) di Ramusiel - Baracòcui (pesche-noci gli stupidi) di Ramusiel - Turcs (discendenti dai turchi invasori degli anni 1477 e 1499) di Ciasarsa - Scussòns (maggiolini) di San Lurìnz - Morsàn da li àucis (Morsàn delle oche) - Codàrs de Tajet (codàrs perso, da cui l'avviso in chiesa) - Siètin, (Settimo di Cinto C.) non rubar - Tièz de la britule - Rosa cun la gosa (gozzo, per l'acqua) - Ligugnana mangià puc, ma ridi tant.
Concludiamo col vecchio consiglio, per star bene: acqua de le Torate, vin de Lison (bianco), vin de Pramajor (rosso).
Opere poco note di Vincenzo e Guido Cadorin nella destra Tagliamento
GIACOMO TASCA
La famiglia veneziana degli scultori e architetti Cadorin era originaria del Cadore come lasciò scritto Ettore Cadorin, figlio di Vincenzo, nelle sue “Note di un artista veneziano”. Egli attestò che la sua famiglia si era trapiantata a Venezia nella parrocchia di S. Maria Maggiore nei primi anni del Seicento. Attività tradizionale dei Cadorin erano la scultura e l'arte decorativa con l'intaglio e - nel Settecento - la doratura e pittura del legno analogamente ad altri artigiani e artisti di origine alpina, tedesca e olandese.
Vincenzo Cadorin (Venezia 1854-1925), seguace del Dupré ma aperto e raffinato artista animato da autentici slanci romantici, ebbe come diretto maestro di scultura all'Accademia di Belle Arti il Benvenuti e da allora continuò a coltivare sempre con i numerosi insegnanti dell'Accademia uno stretto rapporto di amicizia e sentimento di ammirazione in particolare con la scuola di Dal Zotto, maestro dello stile “verista” che Cadorin adottò fin dai primi anni del Novecento ma - come scrisse Marchiori - restando fedele di quel “vero al quale mirava con spirito antico e con la tenacia tradizionale dei suoi avi”. Trasmise questo fecondo rapporto con gli insegnanti dell'Accademia ai suoi figli Ettore e Romeo che furono a loro volta scultori, alla figlia Ida pittrice e all'ultimo degli undici figli, Guido, che affidò alla scuola di pittura di Cesare Laurenti.
Il primo successo Vincenzo Cadorin lo aveva colto a Roma con alcuni lavori in bronzo e in legno presentati ad una mostra collettiva nel 1893; era seguita la medaglia d'oro conquistata con un bellissimo nudo femminile intitolato Flora alla esposizione di Torino del 1884; due anni dopo eseguì le boiseries dello scalone della villa della regina di Sassonia a Dresda che andò distrutta nel bombardamento aereo del 1945, nel 1888 scolpì in avorio una Madonna per l'imperatrice di Germania moglie di Federico di Prussia; nel 1899 una sua scultura, la Primavera, un gesso bronzato esposto alla III Biennale d'Arte di Venezia, fu acquistato dalla regina Margherita di Savoia che da anni era diventata una sua fedele e convinta ammiratrice e gli aveva ordinato la decorazione della cappella privata di Roma (oggi queste opere si trovano nella chiesa di Sabaudia). Nel 1895 fu chiamato a Padova nella basilica di S. Antonio per modellare gli ornamenti ancora mancanti delle porte di bronzo e a completare l'altare di Donatello con il trono di legno dorato. Altri troni riccamente dorati e finemente intagliati furono tra le sue creazioni più gradite dal gusto popolare come quello della Madonna della Salute a Venezia, dono dei veneziani a Pio X (1908), quello della Madonna del Popolo di Verona (fig. 1) e quello scolpito per l'aula magna dell'Ateneo di Bucarest (1897).
Della figura fisica e del portamento di Vincenzo Cadorin ha scritto un vivace ritratto Giuseppe Marchiori: “…era alto un metro e ottantotto centimetri…con la barba rossiccia, le folte sopracciglia, magro, quasi ossuto, il saggio Cadorin appariva accigliato e laconico come gli artisti dell'epoca, parchi in fatto di teorie e pronti invece a parlare del “mestiere” tramandato di padre in figlio” e più avanti aggiungeva “leggendo le memorie scritte da lui si ha l'impressione che il tempo si sia fermato al Vasari”.
Nel 1910 il figlio Guido ne fece il ritratto (fig. 2) nella consueta posizione che il padre assumeva quando lavorava in camice bianco con la sgorbia ad un busto di legno con lo sguardo puntato sull'intaglio.
Con il passare degli anni, di fronte al mutare del gusto e dello stile artistico, Vincenzo Cadorin, pur restando coerente nel modo di sentire e di ragionare che gli era innato e che era il vero motivo dei suoi successi, avvertì la forza del nuovo che bussava alla porta del suo studio e così, quando il Liberty fece capolino a Venezia, non ebbe dubbi nell'accettarne il messaggio: di questa evoluzione sono prova i due corpi femminili e i rami vegetali scolpiti insieme per un mobile portafiori (fig. 3). L'importanza fondamentale che la natura nelle sue espressioni del mondo vegetale e della vita umana esercitò sull'animo e sul carattere di questo artista fu messa in risalto da L. Càllari nella edizione del 1900 del Thieme-Becker con queste parole: “…proveniente da uno studio approfondito delle migliori opere di intaglio del Rinascimento e del mondo delle forme vive della natura, ha cercato di indicare nuove strade dell'intaglio e dell'arte decorativa veneziana con una stilizzazione moderna e personale delle forme della natura liberamente scelte”.
Fu nel 1911 che Vincenzo Cadorin conobbe don Celso Costantini, nativo di Castions di Zoppola, che dal 2 Marzo 1901 era diventato vicario del Capitolo della Diocesi Concordiese per la parrocchia di Concordia Sagittaria. Quello che nel 1952 sarebbe diventato Cardinale di S. R. Chiesa dopo una vita avventurosa e intensamente vissuta tra Aquileia, Fiume nel periodo dannunziano, Pechino e Roma, aveva già fondato una Società degli Amici dell'Arte Cristiana e la omonima rivista - tuttora pubblicata - suscitando entusiasmo nella maggior parte del Clero e dell'Episcopato Italiano. Il Costantini aveva utilizzato i ritagli di tempo libero per “modellare qualche figura” come scrisse nelle sue memorie. Acquistò da Vincenzo Cadorin per la chiesa Cattedrale di Concordia “il simulacro della vergine. Egli mi diede qualche istruzione. Mi illusi di poter portare un contributo alla rinascita di quella cenerentola che è l'arte cristiana”. Nonostante i consigli di continuare a interessarsi di scultura, dopo aver lasciato opere sue di carattere sacro e profano a Concordia, a Portogruaro e nelle case di parenti e amici a Sesto al Reghena, San Vito al Tagliamento, Castions e a Murlis di Zoppola, don Costantini decise di smettere con la scultura ma mantenne vivi rapporti di amicizia con Vincenzo Cadorin.
Nomi di luogo e leggende nella Bassa friulana
BENVENUTO CASTELLARIN
Premessa
Sappiamo che la fantasia o l'immaginazione dell'uomo non ha praticamente limiti. La storia dell'uomo è costellata da racconti leggendari, fantastici. Prendiamo ad esempio le leggende epiche medievali che pur riferendosi a personaggi, luoghi, epoche e avvenimenti reali, contengono elementi fantastici presi anche dalle tradizioni orali. Dalla fantasia sono nate e sviluppate le fiabe, i romanzi. Non ci sono ambiti in cui la fantasia non sia stata evocata. Non sono esenti i nomi di luogo, ai quali, alle volte, vengono loro attribuite delle spiegazioni fantastiche con il supporto magari dell'idioma locale. E' il caso per il nostro territorio del latisanese di Teor: te adoro; di Chiarmacis (Teor): cjâr e macjs, carro e pertiche verticali dello stesso; di Sella (Rivignano): sêle, seglot, secchia, secchio; di Morsano al Tagliamento: môr san, muori sano; di Bando (luogo comune in più località): di bant, a gratis; di Latisana: tisane (tisana) o là ti sana; di Pertegada (Latisana): part teade, parte tagliata; del fiume Tagliamento: taglia e metti, oppure del torrente Cormor: al cor e al môr, corre e muore, l'elenco potrebbe continuare con molti altri esempi.
Nomi di luogo attribuiti al passaggio di Attila
Esistono anche dei nomi di luogo fantasiosi legati a fatti realmente accaduti o a dei personaggi storici realmente esistiti. E' il caso di Attila, il crudele e sanguinario capo degli Unni che nell'anno 452 d.C., giunse con le sue truppe in Friuli fin sotto le mura della città di Aquileia. Attila, vedendo lo splendore di questa città, che per grandezza era la nona città dell'Impero romano, la cinse d'assedio. La città che non era mai stata conquistata da nessuno, si preparò a sostenere anche quest'assedio. Dopo diverse settimane di attesa, poiché gli aquileiesi resistevano tenacemente ai loro assalti, Attila ordinò di togliere l'assedio e di andare a conquistare altre città. Proprio quando stava per partire vide una cicogna con i sui piccoli abbandonare la torre della città, Attila allora capì che gli aquileiesi erano senza viveri e sul punto di arrendersi. Allora egli ordinò di attaccare la città gli aquileiesi, stremati, non poterono opporsi ad un così grande esercito e dovettero soccombere. Attila, per il tempo che perse durante l'assedio era talmente infuriato che distrusse interamente la città e la depredò di tutti i suoi tesori.
Non contento di ciò, Attila nel dirigersi verso Concordia, se la prese anche con i piccoli villaggi. Si racconta, ad esempio, che arrivato nelle vicinanze di un villaggio della nostra zona lo distrusse lasciando intatto solo un palazzo, per questo fatto il paese sarà chiamato Palazzo Solo e, per dare credito alla leggenda a Palazzolo (dopo il 1871 Palazzolo dello Stella), si indica tuttora il palazzo risparmiato da Attila, chiamato appunto “Palazzo, o casa di Attila”: un rudere presso Duino è pure chiamato il “Palazzo di Attila”, perché sembra che il re lì vi abbia pernottato una notte).
Non soddisfatto, Attila dopo aver oltrepassato il fiume ora chiamato Stella, si diresse verso nord dove trovò un altro borgo: lì ruppe solo la riva di un piccolo argine. Per questo fatto il paese sarà poi chiamato Rivarotta.
La fama di Attila che distruggeva tutto quello che si trovava lungo il suo cammino era arrivata fino ai più remoti villaggi. Appena si spargeva la voce che Attila stava per arrivare, ognuno cercava un sicuro nascondiglio per potersi salvare. Così Attila, dopo aver lasciato il villaggio di Rivarotta, proseguì per quella strada incontrando un altro piccolo nucleo di case. Qui, al contrario, vi era rimasta coraggiosamente una famiglia composta di due vecchi genitori e una figlia, la quale, sfidando il crudele condottiero, si presentò sulla strada.
Attila rimase folgorato dalla sua bellezza e del suo coraggio, e subito le chiese di diventare sua sposa, in cambio avrebbe risparmiato la vita ai suoi genitori e la distruzione del villaggio. La giovane accettò e allora Attila pronunciò la celebre frase: «Per amore di questa giovane, in drio te lasso». Da questo fatto il paese prese il nome di Driolassa.
Non così fu la sorte di un altro vicino villaggio dove la soldataglia di Attila fece un vero sterminio lasciando intatto poco o niente. Per questo il paese prese il nome di Pôc e nie - Pocenia.
Arrivato che fu Attila presso le rive del fiume Tagliamento, si accorse che era in piena, e, vedendo questa gran massa di acqua, pensò di non avventurarsi ad attraversarlo con il tesoro razziato ad Aquileia ma di sotterrarlo per poi riprenderlo al ritorno.
Per ricordarsi il punto esatto lo sotterrò vicino all'ancona di Santa Sabida che si trova tuttora tra Ronchis e Fraforeano vicino l'argine del Tagliamento.
Le notizie delle grandi distruzioni operate da Attila in numerose città, indusse il papa, prima che Attila distruggesse anche Roma, ad andargli incontro per indurlo a fermarsi. Il papa riuscì nel suo intento, ma si afferma, che dopo quell'incontro Attila perse completamente la memoria, e quando ripassò un'altra volta il Tagliamento per ritornare in Ungheria, non si ricordò più dove aveva nascosto il tesoro. La notizia di questo tesoro nascosto si perpetuò nei secoli e indusse più di qualche persona a scavare nei pressi dell'ancona di Santa Sabida senza per altro trovare nemmeno una moneta o un gioiello d'oro dell'immenso tesoro di Attila.
Sempre a riguardo del tesoro di Attila a Marano è viva ancora la leggenda secondo cui il re degli Unni, dopo aver distrutto Aquileia, mentre transitava con il suo esercito nei pressi della laguna di Marano, vide un isolotto ben protetto dal mare e nascosto da una folta vegetazione, tanto che pensò che fosse il posto ideale per nascondervi il tesoro accumulato con razzie e saccheggi. L'isolotto, secondo alcune testimonianze orali, sarebbe quello denominato Bioni o Biuni (luogo ubicato a sud ovest di Marano). Questa leggenda si è forse radicata nella fantasia popolare, poiché nei suoi pressi sono stati rinvenuti molti reperti di epoca romana.
Il Territorio
In epoca romana, il territorio comunale del fundum Mucianum com'è noto, è stato attraversato dalla via consolare Annia, un'importante via di traffico stradale che lo collegava ad Aquileia e la via fluviale dell'Arvuncus/Revonchio non lontano dall'Anaxum/Stella. Inoltre, la natura geomorfologica ed edafica del suolo, ricco di limi ed argille, su cui si sviluppavano estese foreste di latifoglie, fecero del territorio una delle zone più produttive di materiale fittile dell'agro aquileiese.3
Le numerose fornaci infatti - attive già nel primo periodo di sviluppo della città romana - fornirono ad essa ed alle ville rustiche sparse sull'agro, i laterizi necessari per erigere le mura degli edifici e la loro copertura con tegulae. Il prodotto fittile finito, fu con tutta probabilità trasportato ad Aquileia sfruttando la via fluviale dell'Arvuncus e che presso la sua foce adiacente a quella dell'Anaxum (Portus Anaxum), seguiva verso est la direttrice lagunare per giungere alla foce dell'Alsa (Portus Alsa), per raggiungere infine Aquileia risalendo il fiume Natiso/Natissa.
I reperti fittili di superficie, numerosi e ricchi di scarti di lavorazione, raccolti a ridosso del tracciato stradale dell'Annia (sito MdT 005)4 e, nei pressi dell'attuale centro storico (sito MdT 007, MdT 008 e MdT 009), fanno ritenere con sufficiente certezza, che le fornaci produttive di laterizi con bollo impresso, fossero numerose e attive in loco.
Nel periodo di massimo sviluppo edilizio della città romana, l'attività delle locali fornaci, si sviluppò al punto di rendere necessario differenziare il prodotto mediante l'uso della stampigliatura dei bolli, già dagli inizi del I e forse dalla fine del II secolo a.C.5
La maggior parte di essi, pur tuttavia, rimane di difficile collocazione cronologica in quanto i marchi impressi sono di forma estremamente semplificata, privi di cartiglio, scritti su un'unica riga e senza indicazioni utili per una loro datazione.6 Per questo motivo, tuttora, la loro datazione può basarsi solo su un'analisi tipologica, paleografica e prosopografica. Nei primi anni '80 del Novecento però, un elemento nuovo e utile alla collocazione cronologica dei bolli avvenne con la scoperta del relitto di un'imbarcazione romana sul fondo del fiume Stella (Anaxum).7 Dal suo carico ricco di tegulae stampigliate con bollo in planta pedis si potè datare l'imbarcazione alla seconda metà del I secolo d.C. ma anche i bolli gentilizi delle gentes locali produttrici dei laterizi.
Nell'epigrafia lapidaria della città di Aquileia, trovano conferma alcune di queste, attestando così l'influenza che esse dovettero avere nel potere politico e nell'economia della città, dovuto anche a legami di parentela con i domini locali. Si ritiene che molte di queste gentes provenissero dal Centro Italia, nel momento della deduzione della città, trasferendo in loco l'attività già avviata nel luogo d'origine.8
I frammenti inediti
Uno dei tre bolli presentati in questo contributo, è stato rinvenuto poco a sud del centro storico di Muzzana nel sito MdT 009 Baroso, ed è da collocarsi cronologicamente in età tardo-repubblicana. Riporta stampigliato il bollo gentilizio C.ARATRI, con un nesso tra la lettera A e la T. Il frammento di tegolone pur lesionato da ripetuti contatti con i mezzi agricoli, conserva ancora leggibile la scritta “…RATRI”, a lettere capitali incavate e che ci permette così di identificarne il produttore.
Il confronto in questo caso, è fatto con i numerosi e simili frammenti di tegoloni bollati conservati presso il Museo Civico di Udine e provenienti dal sito MdT 005. Tutti i laterizi hanno il bollo libero, noto in quattro varianti differenziate esclusivamente dalla tipologia del punto diacritico.
San Paolo, san Polo intinerari devozionali nelle basse e non solo
ROBERTO TIRELLI
E' cosa abbastanza rara che il patronato di una chiesa e di una pieve, soprattutto, venga attribuito alla “Conversione di San Paolo” con festa nella ricorrenza liturgica del 25 gennaio. Nel Patriarcato di Aquileia due sono le pievi che hanno questo medesimo patrono: Mortegliano e San Polo di Piave.
Quest'ultima sino al 1818 è stata una della cinque pievi assegnate al Patriarca e poi all'Arcivescovo di Udine, pare ancora al tempo dei Longobardi, affinché potesse guadare in tutta sicurezza la Piave per raggiungere alcuni suoi domini spirituali e temporali nel resto dell'Italia settentrionale. E infatti sino al 1866 si chiamava San Polo del Patriarca.
Che cosa unisce Mortegliano a San Polo? Nello spazio geografico quasi a metà strada fra le due località troviamo San Paolo al Tagliamento, pure prossima al passaggio di un fiume. Mortegliano, però, non si chiama San Paolo né è vicina ad un importante corso d'acqua.
Evidentemente a noi oggi sfugge il nesso. Qualche studioso ha pensato che nei tre paesi nel profondo Medioevo ci fossero dei possedimenti del celebre monastero benedettino di Sankt Paul in Lavanthal, Carinzia, ma mentre per altre realtà ciò risulta per questi non vi sono tracce. Altri ancora hanno avanzato l'idea che le tre chiese abbiano avuto un unico fondatore, forse proprio un Patriarca del X-XI secolo votato alla devozione paolina. La Chiesa aquileiese, però, tramite San Marco è di tradizione petrina, ma non è da escludere che in un periodo di particolare crisi vi siano giunti dei missionari da Chiese ove invece la tradizione paolina era prevalente.
L'iconografia del santo di Tarso che lo vede portatore di spada, strumento non di offesa, ma di martirio, lo assimila ad altri santi molto popolari nella pianura quali san Giorgio, san Martino, san Michele. In tempi assai aspri la spada ha un valore simbolico molto evidente.
La spada e il libro, altro accessorio che accompagna l'apostolo come riferimento alle sue epistole, possono essere visti come richiamo alla missione del Patriarca (“pastorale e spada” nelle iconografie medievali). Il nodo da sciogliere, però, è il perché si celebri la conversione, ormai chiaramente collocata dalla memoria della Chiesa a fine gennaio come richiamo alla luce che apparve al persecutore Saulo sulla via di Damasco, luce che va crescendo di giorno in giorno dopo il solstizio d'inverno. E', però, una celebrazione di tutta la Chiesa e non soltanto di quella aquileiese.
Bisogna allora andare al significato di una data, arcano che noi uomini moderni non sappiamo interpretare, ma che, per gli uomini del Medioevo, era ben comprensibile.
San Polo, oltre che nell'omonima parrocchia di Venezia, si ritrova nel Friuli orientale a Monfalcone e denomina sia una località sia l'ospedale ed anche qui si può pensare ad un legame con l'acqua poiché poco distante esce dalle viscere della terra il Timavo.
Vi è certamente una linea di continuità nella Bassa friulana che unisce San Polo di Monfalcone, San Paolo di Mortegliano, san Paolo al Tagliamento e san Polo di Piave. E' il passaggio di un corso d'acqua che esige un cambio (come la conversione del santo), un andare da una riva all'altra. Forse è anche il segno di un itinerario di devozione o di pellegrinaggio come lo è la sequenza di chiese dedicate a San Giacomo oppure a San Martino. Vi è sempre sulla stessa linea un San Paolo anche in Slovenia nei pressi del passaggio più agevole delle Alpi orientali. Evidentemente il significato si è andato a perdere con la duplice rottura con il passato alla fine dello scisma dei Tre Capitoli e con l'applicazione del Concilio di Trento.
Pandora, Eva e il femminile. Miti di origine e la riflessione femminista*
(seconda e ultima parte)
CRISTINA BENIGNO
Una rivoluzione epistemologica: la riflessione femminista
Alcune considerazioni preliminari provenienti dall'ambito antropologico.
Il dato oggettivo della generica dualità biologica dell'umano funge solo da base su cui sono culturalmente costruiti: 1. i modelli dell'identità sessuale (cioè il maschile e il femminile per quella cultura); 2. i ruoli sociali rispettivi (l'uomo e la donna per quella cultura, ovviamente sempre in funzione del mantenimento del rapporto procreativo, rapporto imprescindibile pena l'estinzione del gruppo). Ovviamente culturale è il giudizio di valore che ogni gruppo sociale esprime su entrambi i punti precedenti.
L'identità sessuale non corrisponde obbligatoriamente alla morfologia dei corpi, è piuttosto una costruzione slegata dalla determinazione biologica e alcune società ammettono esplicitamente la possibilità di questa divergenza. Si conosce per esempio il caso degli Inuit, riportato da Héritier,71 che annulla ogni possibilità di fraintendimento sulla presunta naturalità delle determinazioni sessuali identitarie e sociali (i 2 punti visti sopra). Tra gli Inuit, popolazione delle zone artiche, l'identità sessuale non è determinata in funzione del sesso anatomico, ma in funzione del sesso dell'anima-nome reincarnatosi nel bambino/a. Avviene quindi che un bambino, morfologicamente maschio, venga cresciuto e considerato una femmina a causa della sua anima-nome femminile, ma questo solo fino alla pubertà. Giunto a questo momento del suo sviluppo deve assumere il ruolo corrispondente al sesso apparente, compiti sociali e di riproduzione, cioè il ruolo di maschio riproduttore e di uomo adulto Inuit. Questa assunzione avviene pur conservando per tutta la sua vita l'identità data dall'anima-nome, cioè in questo caso considerandosi una femmina.
L'esempio Inuit citato da Héritier72 mostra il primato del sistema eterosessuale che determina l'ordine finale dei ruoli, e sollecita l'attenzione su due punti importanti: il fatto che i confini tra i sessi sono costruiti (si parla di costruzione della differenza sessuale a partire da una corporeità solo parzialmente diversa), e la fragilità dei confini stessi, usualmente mantenuti attraverso molteplici strategie educative e repressive; confini che si mantengono sotto la protezione, diciamo così, di una considerazione naturalistica (esiste il maschio, il maschile e l'uomo).
Si conoscono anche casi in cui il centro della questione non è tanto la determinazione dell'identità sessuale (“essere” maschio, “essere” femmina), quanto la scelta del ruolo sociale. Per esempio presso gli Indiani delle Pianure e dell'Ovest Americano si ammette la possibilità che alcuni individui realizzino una “trasgressione sessuale del genere”: un ragazzo diventa donna sociale tramite travestimento e adozione di compiti e attitudini relative a questo sesso.73 Ugualmente una ragazza può diventare uomo sociale. Questi individui si possono sposare e lo fanno con persone del loro stesso sesso, ma di genere opposto: cioè una donna sociale può diventare una delle tante mogli di un uomo, mantenendo una logica di rapporto eterosessuale che copre ciò che per noi sarebbe un caso di omosessualità.
Da notare che qui il passaggio di ruolo non richiede la modificazione del corpo (chirurgia estetica, si veda il caso dei transgender), non tanto per problemi di assenza della tecnologia adeguata, quanto probabilmente perché ci troviamo entro un ambito simbolico differente dal nostro in cui il messaggio creazionista biblico veicola la distinzione netta e inderogabile dell'umano in due corpi, ognuno con il suo sesso, la sua identità sessuale e il suo ruolo ben preciso. Un modello binario in cui le determinazioni non sono mescolabili.
Cognome LUGNAN
MARIA TERESA CORSO
E' probabile che il cognome derivi dall'antico prediale d'origine latina Lugnan (G. Frau) che identifica la penisola di Lignano.
Il cognome Lugnan identifica una delle più antiche famiglie gradesi, un'antica famiglia della Bala d'Oro. Il Dandolo nella sua Chronicon Venetum cita fra le famiglie nobili i Lugnan che nel IX secolo si portarono a Rivoalto e a Venezia dove venne ascritta a quella nobiltà.
Altra ipotesi è che i Lugnan siano arrivati da Pirano o da Capodistria, presenti già nel XII sec. (oggi estinti).
Stemma
“Bandato d'argento e di rosso; col capo del primo caricato di una testa di drago rosso”.
I Lugnan a Marano
Lugnan Agostino, nato circa verso il 1730, confratello della scuola di Sant'Antonio abate, nel 1768 risulta essere capostipite maranese della famiglia Lugnan. Si sposò con Maria Ruffini, che premuore al marito nel 1773. Ebbero due figli: Giorgio nato verso il 1740, pubblico comandador sposato con Marianna Mirandola di Palazzolo, e Giambattista.
Questi erano gli effetti personali di Giorgio Lugnan: “Un paro di calzoni usati color di maron; Un Comesso ed un paro Bragoni di panno color violetto con buse, e bottoni d'oro quasi nuovi; Un paro Bragoni di Roè misto ed un Comesso di camelotto di setta verde con bottoni d'argento usatti; Un paro Calze di setta quasi nove; Un Capello usato; Un Baretton di veludo usatto; Un Codegugno di panno novo”. Giorgio e la sua sposa ricevettero alcuni beni patrimoniali in dote dal padre di lei: un pezzo di terra e Zorzi (Giorgio) acquistò a Palazzolo a fine Settecento in località San Lorenzo due pezzi di terra. Avranno poi un figlio: Zuanne.
L'altro figlio, Giambattista era nato nel 1756, di professione bottegaio, abitante in Borgo Sus, casa mapp. 3 nel 1811 (attuale casa eredi di Ivan Brocchetta) che sposò il 7.4.1800 Teresa Padoan, di Domenico, di professione pescatrice ma, rimasto vedovo, si maritò il 12.1.1813 (di 30 anni più vecchio) con Zentilin Maria Elisabetta, di 27 anni, la giovane vedova di Silvestro Ruffini, rimasta sola nel 1811. (Lei era figlia del resto, di Zentilin Giovanni e Marina Angelini, dunque nipote del notaio Angelini).
Il Giambattista ebbe quattro figli: Fiorina, Santa n.1790, Giorgio nato 1806 e Giovanni Battista.
La Fiorina Lugnan (detta Rositi) s'imparentò con la famiglia Raddi, una delle più facoltose a Marano, essendo stati incaricati di gestire il Fontico in fortezza. Sposò Antonio Raddi, di Domenico nel 1768 e nel 1782, Antonio chiese a Gio.Batta Lugnan, suo suocero, di fargli da pieggio (=garante) nella richiesta di ottenimento di cento ducati al Monte di Pietà di Palma.
Fiorina e Antonio che ereditarono la ‘casa sopra le mure' (mapp.114), ebbero R. Maria, n. 25.6.1786 e R. Agostino, studente in un collegio udinese. Nel carteggio Raddi-Lugnan (1790-91), conservato all'Archivio di Stato di Udine, si può desumere quale fosse la realtà economica in casa Lugnan: il figlio di Fiorina, Agostino, che doveva avere 15 anni nel 1790, da Udine, ogni tanto scriveva delle lettere ai suoi genitori che vivevano a Marano, le quali poi venivano recapitate nei diversi modi, uno era quello più tipico mediante carrozza a cavalli, trainata dal famiglio, garzone di casa Lugnan. Leggendole se ne deduce che a pensione Agostino stava dai Cautero e che nel tempo libero si recava a fare commissioni in città per conto dei genitori: dall'orologiaio, dal libraio, dal venditore di carni.
Dalle lettere si rileva poi che il pievano di S. Andrat, Pietro Pertolis conosceva le famiglie Vatta, Raddi, Angelini, Zaccaria. Inviava saluti a queste famiglie, alla signora Daria, alla signora Santa, alla cognata di Antonio e don Pertolis doveva conoscere bene la famiglia Lugnan, specialmente Fiorina se nelle lettere la chiama comadre (comare) e padrona, una sorta di riverenza del cicisbeo, riscontrabile nella storia letteraria veneziana di fine Settecento.
Lo zio di Agostino, Giovanni Battista, intrattiene con il nipote una fitta corrispondenza, di fatto egli fa l'ufficiale di stato civile dal 15.6.1806 al 1813.
Il nipote Agostino Raddi farà l'ufficiale di stato civile subito dopo, poichè gli succederà, ma per soli tre mesi: dal 1°.1.1841 al 25.3.1814. Agostino riuscì a comprare in Borgo Imperiale casa mapp. 127 oggi ristorante ‘Stella d'oro'.
Lo zio che oltre a fare lo scontro (lo scontro si può ritenere che fosse un moderno ‘direttore di banca', atto a sottoscrivere prestiti o approvarne l'estinzione, dopo aver sentito il Capitolo o Consiglio) delle scuole o confraternite si diletta a fare il letterato e lascia una incompleta poesia nella copertina del registro degli Incanti (APM), un sonetto di pariniana memoria, composta da 14 versi: “Donna che bella sia, e che senza meriti o savezzi…con i suoi… a vostri salotti/che sia docile ingegno e suo…./delli servitori….fatti…”.
Giovanni Battista sposò Nicoletta nel 1781, ebbero Maria nel 1824, sposata nel 1845 con Regeni Pietro di Angelo e Angela, dai quali nacquero tre figli: Francesco nel 1857, Battistina nel 1850 e una creatura morta nel 1859.
Nel 1779 Zuanne, figlio di Giorgio o Zorzi assieme a Cargnello di Palazzolo e il servo di casa Angelini furono testi per il notaio Bertoli di Palazzolo. D'altronde i contatti con la vicina Palazzolo erano piuttosto frequenti da parte dei locali: chi teneva bestiame in soccida, chi acquistava manzi con garanzia fornita dal pieggio, chi a Palazzolo si sposava e dotava la figliola di un pezzo di terra. Il 26.2.1780 i coniugi di Palazzolo Giovanni e Caterina Mirandola donano alla figlia sposata con Lugnan Giorgio un pezzo di terra in dote.
Nell'ultimo ventennio del Settecento le donne Mirandola sposate a Marano con altrettanti giovani del posto sono tre: Marianna, Angela e Natalina, una con Lugnan, un'altra con Vatta, altra ancora con Raddi e tutti e tre sono ottimi partiti dal punto di vista economico. Infatti sono tre famiglie facoltose quelle appena citate, dotate di un cospicuo patrimonio immobiliare, non solo, commerciano in bestiame e vino con la vicina Istria e si accaparrano appalti per la vendita in fortezza di olii, vino, grano.
Si viarzin lis scuelis
DON GIOVANNI SCHIFF
La dottoressa Elvia Perosa Ganzerli, in ricordo del suo passato scolastico (prima maestra e poi direttrice didattica) ci propone la composizione “Si viarzin lis scuelis” di don Giovanni Schiff (Pre' Zaneto) sacerdote, poeta popolare (Porpetto 17.1.1872 - Percoto 4.7.1947), il cui contenuto, ironico e pungente, riporta ad un'epoca trascorsa realmente dalla Scuola italiana. La poesia è stata ripresa da: “Poesiis in furlan”, ultima edizione, Arti Grafiche Friulane, Udine 1977.
- Su mostros, viat a scuele;
no la finiso mai
di rondolâsi chenti?
Avanti… folc-che-us-trai!
- No sèso sglonfs avonde
di lat e di fujazze?
- Hai finît dut jò, mame…
- Cjò…, cjape un'altre cjazze…
Se ti ven là, mostricje…
- Ve', Gjgj mi sbelèe
- Mi spude, mi pizighe…
- Mi nizze la cjadrèe…
- Se mi ven su la pìtime
us moli un furnigot…
- Mangià, jò mame, scuete…
- Sètu ancje tu dismòt?
- Jò no vuei formadi…
- Mamute, a mi cicìn.
- Se no tasês, brus lùdros,
us tiri el fressorìn.
- E jo no voi a scuele.
- No fâmi intosseà!...
- Mi à dit il pai c'o vadi
te braide a vendemà.
- To pari al à une ras'cje:
no sâl che il podestât
nus fâs la multe?
- Jò, mame, soi malât…
- No par mangià galere!
Jò sberli e no mi zove:
frutûs spietàit che us cuinzi
cul mani de la scove!
- Jò côr… Ancje jò, mame.
- Mars sûbit e di corse.
- Un sôl moment, mamute,
c'o cjapi su la borse…
- Vèso capît, salvadis?
Fâ simpri chest fracas!...
No stait migo fermâsi
pe strade a titrà clas,
opûr a fâ baruffe!...
E rispietàit la mestre,
se no a misdì no us moli
né crodie, né minestre.
Sino intindûs, aduncje?
Sintiso la campane?
se no us capite
culì la siciliane.
Un documento del 1912 sulla costruzione della chiesa di Gorgo di Latisana
ENRICO FANTIN
Avevamo già trattato sul numero 64 della rivista, pagg. 49-55, alcune note riguardanti la storia della chiesa di Gorgo e un prestito di denaro, da parte della popolazione di Gorgo e Volta, alla Fabbriceria di Latisana. Detta somma era stata raccolta per la costruzione della nuova chiesa a Gorgo e siccome non era stata ancora istituita a parrocchia detto importo venne incamerato dalla Fabbriceria di Latisana e usato per la costruzione del campanile di Sabbionera.
Le note storiche dell'articolo era stato sviluppato in base a una lettera datata 6 aprile 1927 stilata da Fabbroni Gio Batta, rappresentante la popolazione della Parrocchia di Gorgo e conservata presso lo stesso Archivio Parrocchiale .
Ora, un altro documento, datato 19 maggio 1912 e sottoscritto mediante firma o segno di croce da oltre una quarantina di capi-famiglia delle frazioni di Gorgo e di Volta, avallato poi dall'abate pievano di Latisana sac. Francesco
Masini, ci porta a conoscere meglio le vicende sulle intenzioni della popolazione per la costruzione della nuova chiesa.
Allegato al documento una piantina della chiesuola allora esistente con evidenziato l'ampliamento della nuova chiesa.
All'Onorevole Consiglio Comunale di Latisana
I sottoscritti Capi-famiglia delle frazioni di Gorgo e Volta considerando essersi resa affatto insufficiente la troppo modesta loro Chiesa a contenere la popolazione accresciuta di centinaia di abitanti, i quali, per l'angustia del luogo sacro, in grandissima parte, e con grave incommodo, devono star fuori, sono venuti nella deliberazione di erigere una nuova chiesa dietro disegno di esperto Architetto, ottenuta l'approvazione della Commissione Arcidiocesana dell'arte sacra, come di dovere.
Egli è perciò che abbisognando i suddetti dell'aerea all'uopo necessaria, innalzino istanza a codesto Onorevole Consesso affine di ottenere il terreno del Cimitero soppresso, sito all'intorno della chiesa attuale e di proprietà comunale, nelle proporzioni indicate con carattere rosso sul tipo che si allega.
Le popolazioni suddette hanno sempre fatto plauso e sono concorse a sostenerle spese per le migliorie, saggiamente introdotte nel capoluogo, e sperano a lor volta d'esser favorite nella giusta dimanda, per poi procedere all'ordinazione del disegno della desiderata nuova fabbrica.
Umiliano ringraziamenti ed ossequi.
Il conte Pace di Tapogliano sul Col di Lana
GIORGIO MILOCCO
La relazione oggetto di questa pubblicazione proviene dall'Archivio personale del conte Marino Pace di Tapogliano ora in mio possesso. Scritta a mano in tedesco, successivamente ribattuta a macchina sempre in tedesco1, non riporta sui fogli firma o data di sorta e ha come sfondo il Col di Lana2 che fu conquistato dall'esercito italiano per un breve periodo l'8 novembre 1915. Con un'azione audace vennero piazzate in un tunnel posto sotto la cima 5 tonnellate di gelignite (gelatina dinamite) che il 17.4.1916 vennero fatte esplodere provocando il crollo di circa dieci mila tonnellate di roccia. Gli obiettivi che ci si prefiggevano con tale azione non furono però raggiunti. Il racconto, seppur molto contenuto, ci riporta a quel tempo, e data l'abile stesura, la sua lettura è molto scorrevole e piacevole. I fatti narrati sono inediti in quanto non riscontrabili nelle riviste militari specializzate. A causa proprio della guerra il ricco Archivio Pace di Tapogliano fu quasi completamente distrutto.
A Tapogliano piccolo comune del Friuli orientale, comunque, vivevano sotto lo stesso tetto due fratelli Pace:
Marino di Roldolfo (1892/1963). Possidente e conte. Ufficiale di cavalleria - Oberleutnant K.u.k. Dragonerregiment Nr. 5, Kom. Division. Nel corso del conflitto viene segnalato a Gorlice, Przmysel (Galizia). sui Carpazi (1914) e a Jaslo (1915). Fu fatto prigioniero e inviato in Russia a seguito dell'offensiva del generale russo Aleksej Brusilov (4.6.1916). Grazie alle annotazioni trascritte dal 31.8.1916 sino al 30.9.1917 sulla sua scheda personale, conservata a Vienna presso l'Ostereichisches Staatsarchi, sono noti tutti i suoi campi di prigionia: Kaschukowo, Welotschisk (Wolhynien), Darnitsa (Tschernigow), Kassenipov (Rjasan), Spassk. Prima del conflitto frequentò, assieme ad Edmondo Serravalle di Fiumicello e mons. Francesco Spessot, lo Staatsgymnasium di Gorizia raggiungendo la maturità nell'anno scolastico 1909/1910. Ricoprì la carica di Prefetto di Gorizia negli anni 1943-1945 e quella di sindaco di Tapogliano dal 1921 al 1926.
Guglielmo (1896/1957, detto Willi) sono riuscito ad avere ben poche notizie. Anche lui durante la guerra ricoprì il grado di ufficiale (Leutnant) ma in questo caso nel K.u.k. Feldjagerbataillon Nr.7 - Laibach (composto per l'85% da sloveni e per il 15% da altre nazionalità).
Giacomo Gasparotto e i prigionieri di guerra alleati
CARMELA DE CARO
La resistenza nel Portogruarese tra il '43 e il '45.
I primi raggruppamenti partigiani nel Portogruarese nascono alla fine del 1943: parliamo di piccoli gruppi con poco armamento e simile conoscenza politica. A San Stino di Livenza si forma il gruppo “Livenza”, a La Salute il battaglione “Peruch”, tra Lison e Annone la brigata “Ruspo”, e da Cinto a San Michele gruppi vari.
Esiste, poi, da Portogruaro, Concordia e sino al mare un territorio libero, molto esteso, che permette la circolazione di armi e diventa riparo e nascondiglio per gli sbandati. Nel tempo i gruppi vanno a consolidarsi grazie anche all'ausilio e sostegno di organizzazioni dei paesi confinanti. Negli anni cruciali, comunque, sono presenti nel Portogruarese la formazione “Ippolito Nievo B” con comando unificato nato dalla fusione di reparti “garibaldini e osovani; la brigata “Learco”, la “Marcuzzi”, la “Ruspo”, il battaglione “Bertin” e la brigata “Venezia” al cui interno confluiscono tutte le formazioni partigiane che operano tra il Livenza e il Piave. In particolare il battaglione d'assalto “Peruch” opera nella zona del Livenza, parte integrante della brigata garibaldina “Pellegrini” con base a San Stino.
Nella fascia litoranea comprendente anche la località denominata “Brussa”, si costituisce un distaccamento denominato “Furlan” guidato dal comandante Cornelio Mario Grasso che ha tra i compiti assegnatigli dal C.L.N il recupero e il salvataggio dei soldati alleati in fuga nel basso portogruarese. Questo distaccamento ha l'appoggio di alcune famiglie contadine e, per quanto imponenti fossero i controlli tedeschi e fascisti, riesce a nascondere e far fuggire molti soldati e tra questi molti aviatori neozelandesi.
La fascia litoranea è, infatti, sotto il completo controllo tedesco che la considera zona a rischio di sbarco anglo-americano e per questo non solo ne allaga parte di campagna vicina al litorale ma, ne rafforza le difese con armamento pesante, sbarramento anticarro, trinceramenti e difesa aerea. Le spiagge sono minate, presidiate, delimitate da ben due linee anticarro e collegate telefonicamente al comando della Wehrmacht che ha la propria sede nell'azienda agricola di San Gaetano.
A causa di questi massicci controlli, i partigiani sono costretti a operare all'interno della laguna dove la vigilanza tedesca non è capillare: qui, si estendono i collegamenti fra truppe partigiane e comando alleato, permettendo tra il '43 e il '45, al largo delle spiagge della Brussa, lo sviluppo di un'attività clandestina di sottomarini facenti parte della missione “Nelson” con il compito di evacuare i soldati alleati prigionieri in Italia.
Compito dei partigiani è di collaborare con gli specialisti della missione che porta in salvo ben cinquantacinque soldati alleati. Centro di fatti a dir poco straordinari è la frazione di Villaviera situata sulla strada che da Concordia Sagittaria porta a Castello di Brussa; è in questa località che l'amministratore dell'azienda agricola “Genta”, Giacomo Gasparotto, nasconde decine di soldati alleati e non solo.
Giacomo Gasparotto
Ricostruiamo la figura di Giacomo Gasparotto rifacendoci alle pubblicazioni di Antonio Puppo “Giacomo Gasparotto e i prigionieri di guerra alleati” del '46, a “I luoghi della libertà” di Marco Borghi e a “I silenzi della guerra” di Lucia Antonel. Solo in un secondo momento riporteremo le testimonianze di persone tuttora viventi, che l'hanno non solo conosciuto ma che hanno vissuto con lui e che intendono, con la loro versione dei fatti, dare una visione più ampia degli accadimenti di quegli anni.
Giacomo Gasparotto (Portogruaro 15 maggio 1911, Padova 31 marzo 1982), prima semplice fittavolo, poi operaio, infine amministratore della tenuta “Genta” di Villaviera di Concordia Sagittartia, si ritrova dopo l'8 Settembre '43 a offrire rifugio ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento italiani nell'azienda agricola da lui amministrata. Questo nonostante i rastrellamenti e i severi bandi tedeschi che prevedono non solo la confisca di beni ma la pena di morte per chi avesse aiutato o nascosto prigionieri.
Nasconde inizialmente i prigionieri nel granaio dell'azienda all'insaputa della stessa titolare, Marcella Genta, e degli operai che vi lavorano, fornendoli del cibo necessario e di qualche bene di lusso come sigarette e carte da gioco, curandoli in caso di necessità con l'aiuto del dottor Ciangiarotti, primario dell'ospedale di Portogruaro. Con l'aumento del loro numero, si presenta il problema di spostarli. Come fare? Grazie alla conoscenza, forse amicizia col partigiano Ario Polo, Gasparotto, trova la soluzione di farli trasferire in montagna. Qui sarebbero stati al sicuro aggregandosi ai reparti partigiani in lotta contro i nazifascisti che ricevono viveri, vestiario, munizioni e ogni necessità dall'aviazione alleata.
Anche Giacomo avrebbe aiutato la causa con versamento di granturco strappato all'ammasso in Portogruaro (ai padroni Vendrame-Genta avrebbe detto che il granturco era per il mercato nero dove avrebbe reso un prezzo maggiorato). Presto il trasferimento di prigionieri, fatto certamente in piccoli gruppi, diviene difficile per i pressanti controlli, quindi sospeso del tutto.
Gasparotto seguita a tenere il resto dei prigionieri nascosti nella tenuta grazie alla copertura di amici “potenti” che lo informano dei movimenti e rastrellamenti nazifascisti.
E' questa copertura che gli permette di salvare ben sei prigionieri nascosti a Palazzolo portandoli via con un camion carico di paglia o, in altra occasione, liberare prigionieri destinati in Germania, già chiusi in vagoni ferroviari a Latisana, accordandosi con il capostazione affinché facesse saltare i piombi che bloccavano le carrozze. Il treno, trascinato su un binario morto, diventa la salvezza per i malcapitati tanti dei quali si rifugiano a “Genta”.
La guerra pare non avere fine prossima, i prigionieri aumentavano di numero come i controlli, così Gasparotto decide di nasconderli, sempre all'interno di Genta, prima in mezzo a mucchi di canne dove restano tutto il giorno e ricevono cibo di sera o mattino presto uscendo nottetempo per i bisogni fisiologici, poi i singoli mucchi di canne sono sostituiti da un'unica pila circolare, sempre di canne, capace di contenere quaranta persone. Così è più facile gestire i rifornimenti, ma in caso di pioggia difficile il riparo.
Ma le canne non potevano, per le lunghe, essere la soluzione definitiva perché insospettivano la gente che, avrebbe potuto chiedersi il motivo per cui erano lasciate lì a marcire privando gli animali di cibo.
La soluzione definitiva è trovata nel gennaio '44 scavando un rifugio sotterraneo di dodici metri di lunghezza e otto di larghezza ricoperto di letame, all'intero del quale trovano riparo ben quarantasei prigionieri.
Ma poteva Gasparotto fare tutto da solo? Certamente no! Nell'azienda nessuno è informato di quanto accade, nessuno tranne le poche persone di cui si fida; due le donne addette alla preparazione dei pasti e alla pulizia degli abiti, Ines Simon e Marina Soncin, alcuni uomini preposti alla vigilanza: Simon, Botos, Fontanel, il bovaro e pochi altri. E poi le molte coperture: l'amicizia con il comandante tedesco della Todt, l'iscrizione al P.N.F. per allontanare i sospetti, la conoscenza dei comandanti delle forze dell'ordine che rifornisce di benzina (che acquista al mercato nero e nasconde nella casa abitata dal bovaro Soncin).
Sono queste coperture oltre la sua capacità di tenere relazioni con il potere, il godere dell'appoggio e dell'aiuto alleato di cui è persona di riferimento per la salvezza dei prigionieri, che gli permettono di evitare i molti rastrellamenti.
Calendario
GIANNI STRASIOTTO
A fine anno regolarmente, riceviamo vari calendari, a volte anche fantasiosi. Tante le famiglie che possiedono in casa quello di Frate Indovino, con alcuni aspetti della vita di San Francesco, i consigli per l'orto e la campagna, proverbi, detti, curiosità, ecc. Un tempo nella casa del contadino entrava un unico calendario, il popolare Schieson Trevisan, (nato nel 1717, si stampa ancora) con “el pronostego” sulle previsioni del tempo valide per tutto l'anno.
Calendario deriva dal latino calendarium, che viene da calendae, il primo giorno di ciascun mese in cui dovevano essere pagate le tasse e gli interessi sui debiti, propriamente il libro dei crediti.
Il calendario romano, secondo la tradizione, fu istituito da Romolo nel 753 a.C. e nel corso dei secoli subì diverse variazioni. Quello attuale “gregoriano” fu introdotto il 4 ottobre 1582 da papa Gregorio XIII e modificava l'ultimo calendario romano il “giuliano” voluto nel 46 a.C. da Gaio Giulio Cesare. Questo calendario, sempre basato su 365 giorni e l'aggiunta del 366° ogni quattro anni, non trovava corrispondenza nell'anno solare astronomico, mediamente più corto di 11 minuti l'anno. Lo scarto aveva portato al fatto che nell'anno 1582 l'equinozio di primavera, anziché cadere il 21 marzo, corrispondeva all'11 marzo, generando problemi per calcolare il giorno di Pasqua. Papa Gregorio creò una commissione di esperti che finì con cancellare dieci giorni - dal quattro al quindici ottobre - ed eliminò tre anni bisestili ogni quattro secoli, per far coincidere l'anno solare con quello astronomico.
Fra i calendari del passato ricordiamo nell'antichità quello “egiziano” che era simile al nostro attuale. La durata dell'anno era infatti di 365 giorni, divisi in 12 mesi di 30 giorni, più 5 giorni soprannumerari che formavano un piccolo mese a sé. Più recente il “Calendario repubblicano”, introdotto durante la Rivoluzione francese. Fu usato per 13 anni, a partire dal 22 settembre 1792 e abolito il 1° gennaio 1806. L'anno era composto di 12 mesi di 30 giorni, suddivisi, anziché in settimane, in tre periodi di 10 giorni. Il Capodanno era fissato al 23 settembre, data dell'equinozio d'autunno. A ogni anno erano poi aggiunti 5 giorni in più, che diventavano sei per l'anno bisestile. Furono cambiati i nomi dei mesi. Nell'ordine, dall'inizio dell'anno: Pluviale, Ventoso, Germinale, Floreale, Pratile, Messidoro, Termidoro, Fruttidoro, Vendemmiaio, Brumaio, Frimaio, Nevoso. Durante l'era fascista, iniziata con la Marcia su Roma il 28 ottobre 1922, entrò in vigore (ma solo dal 1927) l'obbligo di aggiungere un numero romano accanto a quello dell'era cristiana. Il primo dell'anno dell'era fascista corrispondeva al 29 ottobre 1922. Qualche volta i libri dell'epoca riportano solo l'anno dell'era fascista. La data della cessazione può essere considerata il 25 luglio 1943 (arresto di Mussolini) per l'Italia liberata, mentre rimase in vigore nel nord, soggetto alla Repubblica sociale italiana, fino al 30 aprile 1945.
I nomi dei giorni della settimana derivano dal latino, come quelli dei mesi, anche se i nomi dei giorni hanno origine in Babilonia, dove furono attribuiti ai nomi del sole, della luna e delle divinità di cinque pianeti. La suddivisione della settimana in sette giorni fu adattata in seguito dai greci e romani. I giorni, dalla domenica, sono rispettivamente: giorno del Sole, della Luna, di Marte, Mercurio, Giove, Venere, del “shabath” = “cessare” (ultimo della settimana), per gli ebrei del riposo assoluto e per il mondo romano “saturni dies”, giorno di Saturno, la divinità dell'agricoltura, utilizzato oggi nei Paesi di lingua inglese = Saturday. Per i nomi dei mesi:
Gennaio deriva da ianuarius che significa il mese di Giano (in latino ianus), antica divinità italica, il dio bifronte, nel cui nome si apre l'anno nuovo e si chiude quello vecchio.
Febbraio era il mese dedicato alla purificazione: februarius da februus, “purificante”. Nei giorni dal 13 al 15 ricorrevano delle feste dette Lupercali, durante le quali si compivano solenni sacrifici di purificazione. Il dio Fauno, nella sua accezione di Luperco (una divinità pastorale invocata a protezione della fertilità), era il protettore del bestiame ovino e caprino dall'attacco dei lupi.
Marzo era un mese importante per i latini, sacro a Martius, Marte, che secondo la leggenda era il padre divino di Romolo, fondatore di Roma.
Aprile deriva dal latino aprilis, mese che apre le forze generatrici della natura.
Maggio, da Maia, maius, madre del dio Mercurio. Simboleggia la Terra madre generosa.
Giugno, era il mese consacrato a Iuno, la dea Giunone, divinità del matrimonio e del parto, moglie di Giove e regina dell'Olimpo.
Luglio, dedicato a Giulio Cesare, iulius, il riformatore del precedente calendario, per volere di Marco Antonio.
Agosto, dal latino augustus, ha preso il nome dal primo imperatore dei romani, Carlo Ottaviano Augusto.
Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre derivano rispettivamente da septem, octo, novem, decem, perché erano il settimo, ottavo, nono e decimo mese dell'anno. Il primo calendario romano, infatti, incominciava a marzo. Con la riforma del 46 a. C. slittarono di due posti e divennero il nono, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo mese dell'anno.
Anche il calendario dell'antica Repubblica di Venezia iniziava con il 1° marzo e, per evitare confusioni nei documenti, le date erano affiancate dalla dicitura “m.v.” (“more veneto” = secondo l'uso veneto). La tradizione del Capodanno veneto tuttora sopravvive: si festeggia nell'altopiano di Asiago, in alcune zone della pedemontana berica, ecc. In qualche luogo si provocano rumori battendo pentole e coperchi per fare il “fora febraro”, ossia per scacciare il freddo. Sopravvive anche l'uso dei botti - come i bambini facevano anche da noi, quando si usava l'illuminazione a carburo - mettendo cioè questa miscela di ossido di calcio e carbone sull'acqua, contenuta in una buchetta ricavata nel terreno, con sopra una lattina vuota capovolta: l'acetilene così ottenuto provoca uno scoppio e fa saltare in aria la lattina. Meglio non provarci, poiché è pericoloso.
Conflitti territoriali diocesani (il caso di Brussa e Castello) nella bassa concordiense
ROBERTO TIRELLI
Storicamente il governo della Chiesa ha sempre avuto un riscontro territoriale con confini ben precisi. Non per nulla ha assunto dal governo romano tardo imperiale il termine “diocesi” che veniva usato come circoscrizione amministrativa cui veniva preposto un funzionario detto anche “episcopos” cioè sorvegliante. Com'è noto nell'alto Adriatico in origine vi era la Chiesa di Aquileia come metropoli (cioè madre) da cui dipendevano un buon numero di diocesi di qua e di là delle Alpi. Con la caduta dell'impero e le continue invasioni barbariche, le popolazioni insediate lungo la fascia pianeggiante si spostano nelle isole lagunari. E conseguentemente nascono nuove diocesi: Grado (Nuova Aquileia) per Aquileia vetus, Caorle (allora isola) per Concordia, Torcello per Altino etc. La divisione
creata dallo scisma dei Tre Capitoli porta ad una differenziazione fra le sedi in terraferma (scismatiche) e quelle marittime (ortodosse). Quando i tricapitolini ritornano alla ortodossia è inevitabile che si creino delle contrapposizioni soprattutto per quanto riguarda il litorale. A Grado, ad esempio, nella sinistra Tagliamento, apparteneva Latisana. Sulla destra del fiume vi erano non ben delineate le competenze territoriali fra la diocesi di Concordia (cui appartenevano Portogruaro, San Michele etc.) e quella di Caorle, con un conflitto non solo in termini di religione, ma soprattutto di tipo economico trattandosi dello sfruttamento delle terre paludose e delle lagune con gli estuari dei fiumi. La pieve di Lugugnana (oggi frazione di Portogruaro) in questo scenario era considerata fra
le più vaste per territorio ed antiche, tradizionalmente concordiense, e si estendeva dalla terraferma sino alla costa, includendo numerose chiese filiali, alcune individuate altre ancora di incerta collocazione su un territorio che nel corso dei secoli ha subito tali e tante modifiche da perdersi molte delle tracce lasciate dalla storia. Il suo primato spirituale locale configgeva però con Caorle che aveva come dipendenza Cesarolo e altre piccole località fra le foci del Tagliamento e della Livenza. I residui di una tale varietà di presenze diocesane si concretizzano ancor oggi nel caso di due piccoli centri in comune di Caorle, ai margini delle paludi e delle più recenti bonifiche, Brussa e Castello (di Brussa) che appartengono al Patriarcato di Venezia, ma sono praticamente una enclave
nella Diocesi di Concordia-Pordenone. I due piccoli abitati hanno ciascuno una chiesa parrocchiale. San Bartolomeo (un tempo S. Antonio Abate) per Brussa e Regina Pacis per Castello. Quest'ultimo edificio sacro sorge su un terreno di bonifica donato dall'ingegner Giovanni Gasparini, primo bonificatore della zona della Brussa. La prima pietra della chiesa fu posata nel 1945, mentre il 28 novembre 1953 l'edificio venne consacrato dall'allora patriarca di Venezia, Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni XXIII. Insieme i due piccoli centri costituiscono l'unità pastorale più lontana da Venezia e non per questo vengono trascurati, anzi il cardinale Scola si era messo di impegno per farvi una accurata visita pastorale. La geografia antica delle pievi vorrebbe che, invece, appartenessero a
Concordia e nello specifico alla grande pieve di Lugugnana. Quest'ultima dovrebbe essere molto antica e già il titolo di Santa Maria lo manifesta, sorta probabilmente in un momento storico in cui la molteplice presenza di insediamenti sul territorio ne denotava anche la prosperità. Del resto la sostanza del contendere con la Diocesi di Caorle si concretizzava soprattutto sullo sfruttamento delle paludi, delle acque e delle porzioni forestale fra Lemene, Reghena e Livenza. I tentativi di accordo non sono mancati, ma il tutto è sempre rimasto indefinito soprattutto perché i vescovi di Caorle, diocesi piccolissima, annettevano molta importanza all'avere un più vasto entroterra. Nel 1818 con la “De salute Dominici gregis” Pio VII cerca di mettere un po' d'ordine e sopprime, fra l'altro la
Diocesi di Caorle, ridefinendo i confini delle altre ed in particolare del Patriarcato di Venezia che le subentra. Ben presto, però, anche i Patriarchi, forti del loro primato, incominceranno a vedere un po' limitate le dimensioni delle loro competenze pastorali, per cui si prendono porzioni di terraferma a scapito delle diocesi vicine. Nel 1936 tocca a Brussa ed a Castello. L'esiguo numero della popolazione non permette di conoscere se questo passaggio sia stato gradito o meno, anche perché, in verità, pur essendo frazioni di poche anime, il culto è sempre stato assicurato. Da parte concordiense non è venuta meno la rivendicazione circa le due comunità e, di tanto in tanto, si manifesta, peraltro senza esito da parte dell'interlocutore che di volta in volta siede sulla cattedra di San
Marco.
I ragazzi del '99 e cavalieri dell'ordine di Vittorio Veneto
ENRICO FANTIN
Durante la prima guerra mondiale, “ragazzi del ‘99”, era la denominazione data ai coscritti negli elenchi di leva che nel 1917 compivano diciotto anni e che pertanto potevano essere impiegati sul campo di battaglia.
Furono precettati quando non avevano ancora compiuto diciotto anni.
Anche la Bassa friulana diede il contributo con i propri giovani che, appena maggiorenni, furono chiamati a servire la Patria e, negli anni ‘70, ricevettero il meritato riconoscimento per la partecipazione ed il loro coraggioso contributo alla vittoria finale della prima guerra mondiale.
I primi contingenti, 80.000 circa, furono chiamati nei primi quattro mesi del 1917, e frettolosamente istruiti, vennero inquadrati in battaglioni di Milizia Territoriale. Alla fine di maggio furono chiamati altri 180.000 ed altri ancora ma in minor numero nel mese di luglio. Ma i primi ragazzi del 99 furono inviati al fronte solo nel novembre del 1917, nei tragici giorni di Caporetto.
Il loro apporto unito all'esperienza dei veterani si dimostrò fondamentale per la vittoria finale.
Le giovanissime reclute appena diciottenni del ‘99 sono da ricordare in quanto nella prima guerra mondiale dopo la disfatta di Caporetto (24 ottobre 1917), in un momento di gravissima crisi per il Paese e per il Regio Esercito, risaldarono con onore e spirito di sacrificio ammirabili le file del Piave, del Grappa e del Montello, permettendo all'Italia la riscossa nel '18 a un anno esatto da Caporetto con la battaglia di Vittorio Veneto e quindi la firma dell'armistizio di Villa Giusti da parte dell'impero austro-ungarico.
A partire dal primo dopoguerra, il termine “ragazzi del ‘99” si radicò ampiamente nella storiografia e nella pubblicistica italiana da entrare nell'uso comune per riferirsi a tutti i militari nati nel 1899.
Quanti caddero o furono decorati? Non esistono, a quanto pare, dati certi, il ricordo di questi giovanissimi combattenti sopravvive nella memoria popolare.
A Nervesa della Battaglia un'osteria era intitolata ai ragazzi del ‘99 e vi è anche un piccolo quartiere di Santa Croce del Montello definito “città dei ragazzi del ‘99”. Via “ragazzi del 99”, testimonia a Milano la targa affissa sul muro di un edificio sul lato orientale di piazza San Fedele dietro Palazzo Marino, a un passo dalla Galleria.
Ai ragazzi del ‘99 si riferiscono numerosi canti nati dopo Caporetto tra i giovani del fronte ed ancora oggi conosciuti “ Novantanove, m'han chiamato…date un bacio alla mia mamma e alla bandiera tricolor”.
La decorazione italiana per commemorare la Grande Guerra e l'Unità della Nazione
Il 4 novembre 1918 terminava, per il Regno d'Italia, la campagna Italo Austriaca cominciata il 24 maggio 1915. La guerra, la più cruenta vissuta fino ad allora dal giovane stato italiano, vide la mobilitazione di una forza bellica come mai si vide nella Penisola dai tempi dell'Impero Romano: i mobilitati furono più di 6.000.000, tra uomini in armi dei diversi corpi e specialità, ausiliari delle Forze Armate (Croce Rossa Italiana, Sovrano Militare Ordine di Malta, ecc.), operai militarizzati nelle industrie, ecc..
Gli anni della guerra, come ampliamente risaputo, furono lunghi e duri al fronte. Dopo due anni dalla fine del conflitto, nel 1920, con il Regio Decreto n° 1241 del 29 luglio dello stesso anno per appunto, venne istituita la MEDAGLIA COMMEMORATIVA DELLA GUERRA ITALO AUSTRIACA. La decorazione veniva concessa ai militari, ai militarizzati, agli assimilati ed al personale dei corpi e reparti ausiliari, che avessero prestato servizio almeno per quattro mesi in zona di guerra ed in zona giurisdizionale della Armate italiane impegnate al fronte.
Questa medaglia fu portata con orgoglio da tutti gli insigniti, in armi o in congedo. La medaglia, proprio per la sua caratteristica denominazione, riportata infatti anche sul verso della stessa, “coniata nel bronzo nemico”, veniva per appunto coniata fondendo i cannoni tolti agli austriaci.
La decorazione raffigura al recto il busto di S.M. Re Vittorio Emanuele III, il Re soldato come venne chiamato, volto a sinistra, in uniforme da campagna mod. 909 (colletto in piedi, stellette al bavero, ecc.) e con il capo cinto dall'elmetto italiano, di derivazione francese, Adrian mod. 1916. Attorno a questa effige, nel giro, è riportato il motto GUERRA PER L'UNITA' D'ITALIA intervallato fra le parole dalle classiche fronde d'alloro che tanto ricorrono nella simbologia medaglistica italiana.
All'altezza del bavero di S.M., alla destra, è incisa a rilievo la firma dello scultore “S. Canevari”, ovvero Silvio Canevari noto artista dell'epoca.
Al verso è rappresentata una Vittoria alata posata su piedistallo formato da scudi sorretti da soldati italiani. Non è chiara l'origine iconografica di tali scudi, ma svariate ipotesi, li danno come scudi da trincea italiani che tanto hanno accompagnato, nel bene e nel male, la vita dei nostri soldati nella guerra di posizione.
La Vittoria è contornata, come per l'effige del Re al recto, da una frase: CONIATA NEL BRONZO NEMICO. La motivazione di tale frase è già stata spiegata sopra.
L'attacco del nastro sulla medaglia è a staffa a forma parallepipeda. Il nastro della decorazione è identico a quello della Medaglia Commemorativa delle Campagne Risorgimentali italiane: difatti la Grande Guerra è storicamente considerata già da allora l'ultima guerra per l'Unità nazionale e la redenzione delle popolazioni italiane assoggettate al dominio dello straniero.
Il nastro è composto da diciotto righe verticali di eguale larghezza alternate da sinistra dai colori nazionali: verde, bianco, rosso.
Speranza di Pace
MONICA MINGOIA
Speranza di Vita,
Speranza d'Amore,
Speranza che palpita
dentro ogni cuore.
Luce del mondo di popolazioni
che ti stanno invocando
con tante orazioni.
Fermati guerra!
Enorme mostro nero.
Fermati oh sterminio
di persone innocenti.
Oh illuminazione va
nella mente dei potenti!
Tutti ci uniamo in un'unica preghiera
per illuminare il mondo
con la speranza vera.
Speranza di una Pace,
una Pace che sarà.
La sola Salvezza per l'Umanità.
Un'Umanità distrutta,
troppe volte umiliata
da sete di Potere
e da Gloria infangata.
Un'Umanità che chiede:
Dignità e Amore,
mentre imperversa l'Angelo Sterminatore.
La Speranza di un mondo
dove si possa amare
senza la propria Fede per forza rinnegare.
Ognuno ha diritto al libero Pensiero
delle proprie Idee
e ad un proprio cielo…
6° premio Ghin Valerio 16 febbraio 2014
Tema: Risorse della laguna - navigabilità e la nautica dell'area
MARIA TERESA CORSO
La laguna
La nostra laguna si è formata più di 5.500 anni fa, secondo i recentissimi studi (1), provenienti dall'ambito universitario, contornata e ombreggiata dalla gran selva prima di querce poi dai pini, dalle felci, dalle tamerici, da invalicabili intrichi che riflettevano nelle acque stagnanti.
L'area anticamente faceva parte dell'agro aquileiese, formante un quadro storico-sociale in parte da scoprire, se si pensa alla leggenda di Attila del V sec. d.C., allo scisma religioso tricapitolino del VI secolo d.C., e al suo stretto legame con il territorio e con la giurisdizione ecclesiastica che si protraeva fino in Croazia, si può intuire come parte della storia della romana Aquileia fosse anche la storia dei nostri luoghi, laguna compresa.
Si diceva dell'agro aquileiese, appena dopo l'anno Mille Marianum, prima come borgo, poi castrum, entrava a far parte del Patriarcato friulano fin dalla nascita. Infatti, il patriarca Popone che volle rinsaldare la cinta muraria, rendendo l'antica Marianum più sicura, innalzò la torre patriarchina, istituendovi una sede patriarcale, poco più che succursale, dove recarsi per le funzioni propriamente religiose o per cogliere rari momenti per andare a cacciare in laguna.
Restaurando il borgo i patriarchi aquileiesi per oltre tre secoli tennero Marano e la sua laguna legato alla storia friulana e al Parlamento friulano, al quale la comunità partecipava con un cancelliere, rinforzando i legami tra le ville limitrofe. Le rendite pretese dai mansi che circondavano fortezza e laguna, erano un pedaggio consueto, da riscuotere annualmente dai villici proprietari da parte del patriarca: vuoi una spalla di cinghiale, vino, frumento, fave, sorgo, miglio, pesce e altre cose, di cui il luogo doveva essere ricco.
Commerci e risorse in laguna attraverso la Patria del Friuli
Sotto la Repubblica di Venezia la navigazione della laguna, lungo i fiumi veneti e friulani era ben conosciuta e praticata. La navigazione interna, fra gli antichi porti fluviali costruiti dai Paleoveneti o dai Romani, aveva degli ampi sviluppi. La funzione del canale di Bevazzana, oggetto di tanto interesse, per gli evidenti fini cui esso tendeva, ha assunto un aspetto economico ben definito e di enorme importanza. I Veneziani impiegheranno diversi uomini adibiti allo scavo di una fossa (canale) lungo un miglio dalla laguna di Marano (Porto Lignano) fino al fiume, allo scopo di rendere più fluide e sicure le relazioni mercantili con Venezia.
I commerci con l'entroterra e con i lontani luoghi di provvigione dell'olio erano frequenti e costanti ed era piuttosto un male contemporaneo contraffare luoghi e sostanze… poiché anche dalla relazione del luogotenente di Udine, il veneto Andrea Foscolo del 1525, si legge: “ …. Et perché Maran è de grandissimo dano a li dacj di Vostra Sublimità, per el condur de le mercantie prohibite: et similiter perché de Istria se trazeno ogli de Pugia soto pretesto che siano istriani mi par che quela per suo interese, li debja far provision… (= debba prendere provvedimenti)”.
Dalla relazione del luogotenente di Udine Girolamo Morosini, anno 1559: “La contadinanza della Patria è molto povera et aggravata de molte gravezze (= spese)… condutture de Sali si pagano in denari contadi di homeni d'arme et cavai leggieri. … Conducono li roveri alla riva, dove se imbarcano... nel tempo del mio reggimento sono stati condutti roveri numero 6225 et tolpi 3117, che de condutture montano (ammontano) ducati 2255…”.
La costa veniva chiamata riviera già nel 1553, come si evince dalla relazione del luogotenente di Udine Francesco Michiel “… A questo illustrissimo dominio incommodo e danno grande; perché se fariano tanto più securi e patroni de essa riviera unita ai loro porti, como sempre regij hano desegnato de farssi, et per questo effeto hano sempre cercato di usurpar lj confini et lochi de Grao con la sua jurisdition et così delli lidi del suo Dominio: conoscendo bene quanto essa riviera et porti importino al suo Stato: però in questi proximi ani, con l'ocasion dele controversie che moveano a Grao fu per sententia confiscato il fiume del Lisonzo, li qual porti dapoi in essa riviera sono Grao - Buso - Sant'Andrea - Lugnan - Taiamento –Tre Baselege - Caorle - Livenza - Cortelazo - Piave - Tre Porti …”.
Il “fundum Mucianum” note sulle ragioni di una donazione
RENZO CASASOLA
Lo scopo di questo contributo, è quello di far maggior chiarezza sul contesto storico in cui venne citato per la prima volta il fundum Mucianum/Muzzana su un documento scritto - del 21 gennaio 824 d. C.1 - e le ragioni politiche e amministrative che allora ne motivarono la citazione. Questa prima nota, si colloca in un periodo storico decisivo per l'intero Friuli, ovvero tra l'epilogo del regno dei dux forjuliensis langobardorum e l'affermazione dei comes francorum, in cui il patriarcae Aquilegensis ebbe un ruolo di assoluto rilievo.
Muzzana fu comunità già da epoca romana, come attestato dai numerosi reperti fittili rinvenuti da raccolte di superficie sul territorio e nel centro abitato stesso. Il praedium Muttius o Mutius, andrà a definire poi in maniera più specifica, quello che sarà l'abitato e dal quale ne manterrà il nome.2
Senza addentrarci troppo nel periodo romano, nello studio di quella prima citazione del fundum Mutianum, ci soffermeremo ai fatti documentati dalle cronache dell'epoca e, in mancanza di questi, agli eventi concomitanti intercorsi su scala più ampia, extraregionale.
Dal II secolo a. C., periodo in cui fu dedotta la città di Aquileia, venne ampliato e rettificato pure il tracciato viario protostorico che diverrà in seguito la consolare via Annia tra gli anni 156 e 153 a. C. dal console Tito Annio Lusco. Secondo i canoni viari romani. Nello stesso periodo si eressero pure le grandi ville rustiche sull'agro aquileiese, nel territorio della X Regio Venetia et Histria augustea. Alcune di esse, lungo questa importante via di traffico, daranno origine in seguito, ai primi nuclei abitati dei vari praedium assegnati sul territorio centuriato. Da allora, e per molte centinaia di anni, non vi sono citazioni dirette sui pagus minori che ne identifichino le località, fino alla fase finale dell'Alto Medioevo3 - come nel caso di Muzzana - in cui per la prima volta in quel regio documento dell'824 d.C., fa il suo ingresso ufficiale nella storia scritta.
In questo lungo lasso di tempo, ad attestare e a tramandare oralmente dagli antichi abitanti del fundum l'origine romana di molti prediali, è il suffisso -ano, -ana nella Bassa friulana, ed -acco, -icco principalmente nel Medio Friuli. Tra il Tardo antico romano e soprattutto nell'Alto Medioevo di impronta germanica, com'è noto, vi fu scarsità di documentazione scritta, in particolare per i centri minori. Per tale ragione, l'esercizio della memoria (recordatur), fu prassi normale in seno ad una società in cui la scrittura fu un'eccezione. Ecco perché, i pochi documenti pervenutici vanno considerati sempre come fonte preziosa di informazione per leggere più nel dettaglio i nebulosi avvenimenti storici di quel periodo.
Com'è noto, il più antico documento scritto in cui si cita il fundum Mucianum, risale ad un diploma del 21 gennaio dell'824 d. C., in cui l'imperatore dei Franchi Ludovico il Pio - quartogenito figlio di Carlo Magno - registra a Verona la donazione di alcuni beni alla Chiesa di Aquileia (MÜHLBACHER, JOPPI, 1884):
“(…) in finibus Forojuliensibus in villa sine fundo Muciano cum domibus casalibus edificiis terris vineis pratis siluis necnon et in finibus Sclavinie in loco qui dicitur Zellia manentes viginti, quemadmodum hos manentes primum Kadola et postea Baldricus fideles nostri Maxentio patriarche beneficiaverunt, ecclesie sancte Aquileiensi ubi deo auctore predictus Maxentius patriarcha preest sollemni donatione tradere et nostro iure in ius et potestatem predicte ecclesie conferre (…)”.
Lo studioso friulano PIER SILVERIO LEICHT,4 che approfondì lo studio storico del Friuli di quel periodo, a tal proposito nei suoi ‘Regesti friulani 568-833' lo traduce e ci riferisce che:
“824 ~ 21 gennaio, Verona — Lodovico il bonario dona alla chiesa d'Aquileia i beni imperiali (20 masi)5 situati nella villa di Muzzana e concede che i 20 masi in Cilli che Balderico e Cadolao avevano dato in beneficio alla stessa chiesa, le appartengano di piena proprietà”. (Mühlbacher reg. 701).
L'antico praedium, ovvero il podere concessogli dal senato romano al legionario Mutius per i servizi militari resi, viene dunque ceduto a titolo definitivo al patriarca aquileiese Massenzio (811-833), convinto sostenitore della causa carolingia.
Facendo un piccolo passo a ritroso negli eventi storici di allora, l'atto di donazione dell'824 fa seguito ed avvalora una precedente concessione del ‘villaggio fiscale' di Muzzana già assegnato a livello di usufructus dal conte del Friuli CADALDO o KADOLA nell'811 e, in seguito dal suo successore BALDRICO o BALDERICO. A seguire, ripropongo un passaggio del famoso documento di concessione:
“(…) Karolus propter suggestionem Maxentii patriarchae, qui aedem ecclesiae suae olim Aquileiae constituta, ob metu Gothorum et Avarorum derelictam ibidem in pristinum honorem restiturus erat, ex hereditate fratrum Rotgaudi et Felicis Longobardorum cum Rotgaudo duce interfectorum, quae ob infidelitatem eorum secundum legem Francorum vel Langobardorum in publicum devenerat et per beneficium imperatoris a Landulo, deinde a Bennone et hactenus a Bovone possessa erat, res in ipsa civitate Aquileia aut iuxta muros eius sitas ecclesiae S. Mariae Aquilegiensi condonat, excepta tamen portione quam tertio fratri Lodolfo, quippe qui in infidelitatem non perseveraverit, possidendam concedit, et exceptis rebus in aliis locis sitis et illa occasione in publicum redactis quas suae ordinationi reservat (…)”.6
